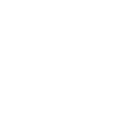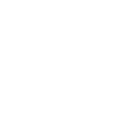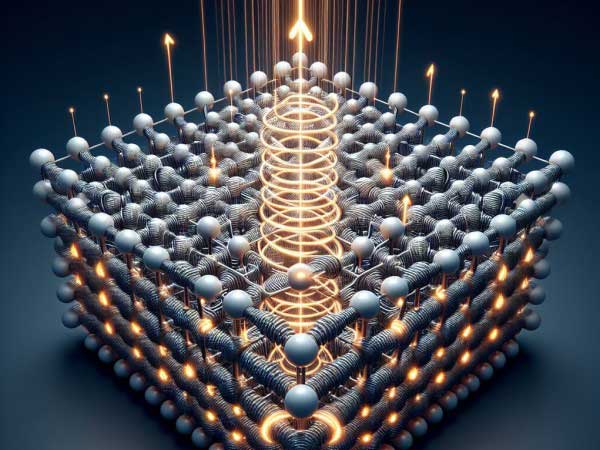Ivan Franceschini è Marie Curie Fellow all'Università Ca’ Foscari e all’Australian Centre on China in the World. La sua attuale ricerca si concentra sulla questione del lavoro in Cina in prospettiva globale, con particolare attenzione ai temi dell’attivismo operaio e della consapevolezza dei diritti tra i lavoratori cinesi. Per un decennio, dal 2006 al 2015, ha vissuto a Pechino dove ha lavorato come giornalista e come consulente nel campo della cooperazione allo sviluppo. «In quel periodo – ci racconta - ho avuto occasione di assistere in prima persona allo straordinario fiorire della società civile cinese in quella che retrospettivamente può essere considerata un’‘età dell’oro’ dell’attivismo e della partecipazione civica in Cina, prima di vederne il declino sotto la leadership di Xi Jinping».
Laurea in Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea e dottorato di ricerca, sempre a Ca’ Foscari, Franceschini ha seguito l’evoluzione delle ONG del lavoro per un decennio, dallo scoppio della crisi finanziaria nel 2008 a oggi.
Negli ultimi anni ha anche lavorato molto in Cambogia, indagando sull’impatto della presenza cinese sulle relazioni industriali nell’industria tessile locale. Negli anni, ha pubblicato una decina libri sulla Cina, su temi che vanno dal traffico di esseri umani ai nuovi media, dalle relazioni industriali alla società civile. Nel 2011, ha collaborato con Tommaso Facchin – anche lui un ex-cafoscarino – per girare Dreamwork China, un documentario sulla nuova generazione di lavoratori migranti in Cina. La collaborazione sta proseguendo ancora oggi e proprio in questo periodo stanno completando un nuovo film sul mondo delle lavoratrici tessili in Cambogia.
Ci può illustrare il contesto sociale e politico cinese nel quale operano le ONG del lavoro?
Queste organizzazioni sono apparse per la prima volta in Cina alla metà degli anni Novanta. Si è sempre trattato di realtà di piccole dimensioni, con una manciata di dipendenti e uffici di fortuna situati per lo più nei pressi di comunità operaie. Tradizionalmente, questi gruppi si sono concentrati su quattro tipi di attività: l’apertura di centri culturali per i lavoratori, in cui offrire corsi su temi specifici oppure organizzare attività ricreative; l’organizzazione di campagne per la disseminazione del diritto, ad esempio attraverso la distribuzione di volantini e altri materiali sulla legislazione sul lavoro; la conduzione di indagini sociali finalizzate alla policy advocacy; e l’offerta di consulenze legali ai lavoratori alle prese con dispute sul lavoro. Poiché si focalizzavano sulla legislazione sul lavoro (e quindi sul discorso ufficiale del diritto), queste attività erano relativamente sicure da un punto di vista politico – dico ‘relativamente’ perché il tema del lavoro comunque rimane molto sensibile per il Partito Comunista Cinese, che ancora oggi continua a presentarsi come l’‘avanguardia della classe operaia cinese’. Tuttavia, insoddisfatte per i limiti evidenti di queste strategie, all’inizio di questo decennio alcune organizzazioni hanno cercato di andare oltre questo approccio ‘legalistico’ e hanno iniziato a promuovere un nuovo approccio centrato sulla contrattazione collettiva, quindi sull’idea che fosse necessario organizzare i lavoratori stessi al fine di metterli in condizione di confrontarsi direttamente con i datori di lavoro. Bisogna sapere che la legislazione cinese non prevede la contrattazione collettiva, limitandosi a contemplare una forma annacquata di ‘negoziazione collettiva’ basata sul presupposto dell’identità di interessi tra i lavoratore e l’impresa. In aggiunta, in Cina non è ammessa l’esistenza di sindacati indipendenti – l’unico sindacato legalmente riconosciuto nel Paese è la Federazione Nazionale dei Sindacati Cinesi (FNSC), un’organizzazione di massa che oggi conta oltre 300 milioni di membri e continua a funzionare come una ‘cinghia di trasmissione’ leninista. Avvenuta nel contesto di una più generale deriva autoritaria del Partito-stato sotto Xi Jinping, la scelta di alcune ONG di adottare una strategia basata sulla contrattazione collettiva ha messo queste organizzazioni in rotta di collisione tanto con il Partito quanto con la FNSC, il che si è tradotto in una durissima ondata di repressione che prosegue ancora oggi.
Ci può parlare dei risultati del suo recente studio sulla repressione nei confronti delle ONG del lavoro in Cina?
Sin dalla loro comparsa, le ONG del lavoro cinesi si sono trovate a confrontarsi con l’ostilità del Partito-stato. Negli anni, attivisti in queste organizzazioni sono stati ripetutamente minacciati con multe, sfratti, arresti, promesse di carriere spezzate. Alcuni sono stati malmenati, mentre i loro uffici venivano depredati. In molti casi, i loro famigliari hanno ricevuto visite minacciose da parte di funzionari di varie agenzie statali. Eppure, queste forme ‘grezze’ di repressione raramente si sono dimostrate efficaci nel dissuadere gli attivisti – in molti casi, hanno semplicemente ottenuto l’effetto opposto, rafforzando la motivazione degli individui in questione. Penso ad esempio al caso straordinario di un lavoratore che tra il 2013 e il 2014 ha trascorso dodici mesi in una cella sovraffollata per aver partecipato a uno sciopero e che dopo la liberazione, invece di rimanere in silenzio, ha deciso di aprire una propria organizzazione per aiutare altri lavoratori. Il punto è che per anni la repressione in Cina è stata un fenomeno ciclico, in cui a brevi momenti di alta tensione succedevano periodi di relativa tranquillità in cui si poteva lavorare con relativa sicurezza. Questo è cambiato con l’ascesa al potere di Xi Jinping nel 2013. Sotto l’amministrazione di Xi, la repressione si è fatta molto più sofisticata e ha assunto caratteristiche permanenti. Questo è avvenuto in almeno due modi. In primo luogo, oltre alla ‘tradizionale’ violenza, negli ultimi anni le autorità cinesi hanno fatto notevoli sforzi per perseguire gli attivisti per vie legali, pubblicizzando ampliamente questi casi giudiziari costruiti ad arte attraverso campagne mediatiche finalizzate a distruggere la reputazione di questi individui, dipinti come burattini nelle mani di ‘forze ostili straniere’. In secondo luogo, il governo di Pechino ha adottato una serie impressionante di leggi e regolamenti sulla società civile che non solo impongono severe restrizioni in materia di registrazione e operatività per le ONG, ma anche limitano fortemente l’accesso a quei fondi esteri da cui organizzazioni cinesi attive in campi politicamente sensibili – quali ad esempio i diritti dei lavoratori – dipendono per sopravvivere. Questi cambiamenti hanno messo a rischio la sopravvivenza stessa delle ONG del lavoro in Cina. Nell’ultimo paio d’anni, moltissime organizzazioni hanno cessato di operare per mancanza di risorse finanziarie. Un paio di organizzazioni continuano ancora oggi a promuovere la contrattazione collettiva, ma lo fanno in maniera molto discreta, tenendosi alla larga da scioperi e proteste e informando chiaramente i lavoratori dei rischi insiti in questa strategia. La maggior parte delle ONG del lavoro ha chiuso i battenti, oppure ha deciso di riorientare le proprie attività trasformandosi in fornitore di servizi per il governo o per le imprese.
Quali sono le possibili evoluzioni della situazione attuale?
Sono appena rientrato da un soggiorno di oltre un mese in Cina, durante il quale ho avuto modo di incontrare alcuni degli attivisti con cui sono in contatto da quasi un decennio. La situazione è drammatica e non accenna a migliorare. Giusto una settimana prima del mio arrivo, il governo cinese ha lanciato l’ennesimo attacco contro le ONG del lavoro, accusandole di essere agenti di ‘forze ostili straniere’ – in questo caso altre ONG basate a Hong Kong – impegnate a sobillare proteste operaie in Cina. L’organizzazione finita sotto attacco non era minimamente coinvolta nei fatti di cui era accusata, ma il governo cinese ha pensato ugualmente di utilizzare ancora una volta le ONG del lavoro come capro espiatorio. Questo per due motivi: innanzitutto, per mascherare la propria crescente incapacità di gestire lo scontento operaio; in secondo luogo, per distrarre l’attenzione del pubblico dal fatto che studenti di alcune università d’élite di Pechino si fossero mobilitati in solidarietà con i lavoratori (per questo sono stati prontamente arrestati). La mobilitazione degli studenti è stata un campanello d’allarme per il Partito, questo non solo perché questi giovani descrivevano la propria lotta riappropriandosi del lessico ‘maoista’ della lotta di classe, ma soprattutto perché l’alleanza tra lavoratori e studenti riportava alla mente mobilitazioni d’altri tempi, non da ultimo gli eventi della primavera del 1989. Il punto è che eliminando dalla scena le ONG del lavoro – la cui enfasi sulla legislazione del lavoro esercitava un’influenza moderatrice sulle proteste operaie in Cina – il Partito ha creato un vuoto che rischia di essere riempito da altri attori con istanze politiche più radicali. Senza il pragmatismo delle ONG del lavoro, c’è la possibilità che i lavoratori avanzino richieste ben più radicali che non la semplice applicazione delle norme sul lavoro già esistenti o la pretesa di sedere a un tavolo di trattativa con i datori di lavoro. Questo non è certo un male, ma inevitabilmente si tradurrà in un irrigidimento delle posizioni del Partito – soprattutto nel contesto dell’attuale rallentamento della crescita economica cinese e della guerra commerciale con gli Stati Uniti.
La rivista che ha fondato, Made in China Journal, è diventata un punto di riferimento anche per una vasta comunità di attivisti e policy-makers. Articoli apparsi sulla rivista sono stati citati una dozzina di volte nell'ultimo rapporto annuale del Congresso Americano sulla Cina. Ci può raccontare l’idea che sta alla base di Made in China?
Il Made in China Journal – che curo con Nicholas Loubere dell’Università di Lund – è nato all’inizio del 2016 con l’intenzione di creare un ponte tra la comunità accademica impegnata in ricerche su temi politici e sociali in Cina – in particolare in materia di lavoro, società civile e diritti – e un pubblico più generale. A quasi tre anni di distanza, credo di poter dire che l’esperimento sta funzionando. A oggi abbiamo avuto la fortuna di contare su oltre un centinaio di autori basati in decine di istituzioni in tutto il mondo. Tutti questi contributori – alcuni agli inizi della propria carriera, altri già affermati nel proprio campo – hanno dimostrato una straordinaria disponibilità. Non solo hanno accettato di scrivere per noi in un linguaggio molto diverso da quello delle altre pubblicazioni accademiche cui sono generalmente abituati, ma hanno anche risposto con straordinaria pazienza ai nostri infiniti commenti e revisioni. Per quanto riguarda i lettori, negli anni abbiamo ottenuto un seguito affezionato di persone che scaricano le nostre pubblicazioni, le condividono sui social media e le discutono privatamente o in pubblico. Alcuni numeri della rivista sono stati scaricati più di 16,000 volte, un buon risultato se si pensa agli standard delle pubblicazioni accademiche attuali. La lista dei nostri iscritti poi rivela come la rivista abbia un certo seguito non solo tra accademici, ma anche tra giornalisti, sindacalisti, attivisti, e policy-makers, il che era uno dei nostri obiettivi sin dall’inizio. Made in China rimane un progetto in continua evoluzione. Al momento stiamo lavorando su tre fronti. In primo luogo, presto sposteremo la rivista su un nuovo sito che speriamo sarà più funzionale e facile da consultare. Nel fare ciò, ristruttureremo il nostro gruppo editoriale per includere esperti in aree in cui finora ci siamo dimostrati piuttosto deboli, ad esempio in materia di questioni di genere. In secondo luogo, stiamo stabilendo collaborazioni con altri media che condividono i nostri principi. In particolare, abbiamo appena lanciato una collaborazione con il sito accademico cinese CNPolitics per rendere alcuni dei nostri contenuti disponibili in cinese e con Hong Kong Free Press per distribuire alcuni nostri articoli sulla loro piattaforma. Infine, stiamo per lanciare una nuova serie di libri open access, che si affiancherà alla serie di Made in China Yearbooks che già pubblichiamo con ANU Press. Il primo volume – in uscita nel marzo del 2019 – sarà una sorta di dizionario critico del comunismo cinese intitolato Afterlives of Chinese Communism in cui raccoglieremo oltre cinquanta saggi scritti da altrettanti accademici in diverse discipline sparsi in tutto il mondo.
Perché ha scelto di lavorare in modalità open-access?
Tutte le iniziative targate Made in China – la rivista, i libri, le summer school – sono interamente gratuite e tali rimarranno in futuro. Questo perché io e i miei collaboratori crediamo con convinzione nell’importanza dell’open access come strumento per tutelare la libertà accademica e la libera circolazione delle idee. Questo è ancora più rilevante nel campo degli studi sulla Cina. Nell’ultimo paio d’anni, diverse case editrici accademiche internazionali hanno ceduto alle pressioni esercitate dalle autorità cinesi e, senza alcuna vergogna, hanno bloccato l’accesso a contenuti scomodi dai propri siti in Cina. Altri editori non hanno esitato a ricorrere a forme più subdole di auto-censura per non rischiare di perdere accesso al mercato cinese. Concentrando l’attenzione sulle responsabilità – gravissime – delle autorità cinesi nel limitare la libertà accademica in Cina e all’estero, si rischia di perdere di vista il fatto che situazioni del genere sono inevitabili quando l’editoria accademica cessa di essere un servizio pubblico e comincia ad essere dominata da logiche puramente commerciali. Poiché gli editori, preoccupati di perdere accesso ai profitti derivanti dal mercato cinese o altri benefici di natura economica, non sono disponibili a prendere una posizione ferma contro ogni forma di censura, l’unico modo di contrastare questi fenomeni consiste nell’eliminare il profitto dall’equazione, riappropriandosi dell’editoria accademica tramite iniziative open access. Il nostro Made in China Journal è un esperimento in questo senso.
Lavoro e diritti nella Cina di Xi Jinping. Gli studi (open access) del ‘Marie Curie’ Ivan Franceschini