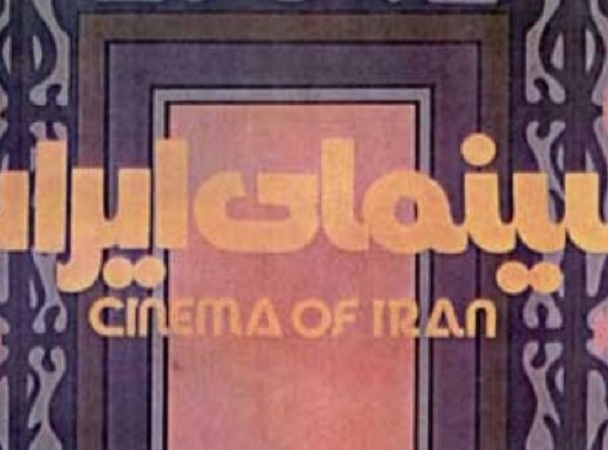VIAGGIO IN IRAN: IL PAESAGGIO NEL CINEMA IRANIANO
"Ove mai degli autunni che verranno Potrà dire una bocca Con disegni di fiore L'incanto del viaggiare?" Le membra del paesaggio, Sohrâb Sepehri
Introduzione: voyeur e voyageur Inizia così E la vita continua, film di ‘Abbâs Kiârostami che si ispira ad un fatto vero (il terremoto del 1990) e che narra la storia di Farhad, un regista cinematografico, e di suo figlio Puya, partiti da Teheran alla volta di Kokér per cercare, tra i sopravvissuti, due giovani attori non professionisti che avevano recitato in una precedente pellicola di Kiârostami (Dov'è la casa del mio amico) ambientata proprio nel Gilan. Nella prima sequenza della pellicola ritroviamo una perfetta sintesi della relazione che intercorre tra cinema e paesaggio, tra arte delle immagini e delle rappresentazioni e materia da rappresentare. L'episodio appena descritto non funge soltanto da introduzione al film – le "avventure" di Puya e Farhad cominceranno, in effetti, dopo i titoli di testa e si trasformeranno, ben presto, in un itinerario di scoperta e testimonianza della profonda umanità che cova nell'animo delle popolazioni terremotate, di chi lotta, giorno per giorno, contro il trauma della morte e del dolore – ma manifesta, attraverso poche e simboliche azioni, la prospettiva stilistica e morale adottata dal regista per narrare un soggetto così delicato: il paesaggio (in questo caso un paesaggio terremotato, ma il discorso può essere generalizzato) entra nel cinema come la cavalletta all'interno dell'automobile (doppio della "macchina" da presa), in un moto di ingenuo entusiasmo (Puya e la convinzione di poter allevare l'insetto) e, nel contempo, di consapevole e inevitabile rifiuto (Farhad che invita il bambino a disfarsi dell'animale). Da una parte la settima arte cerca di catturare il fascino della natura, la mutevolezza di ogni territorio, le dinamiche degli spazi, i giochi di luce, dall'altra toglie alla materia la sua caratteristica principale, la concretezza, la tangibilità, svellendo ogni luogo dalla sua topografia fisica per trasferirlo in un territorio geografico virtuale, quale può essere considerata la finzione cinematografica. All'interno di questo processo di creazio-ne/distruzione della natura un ruolo speciale è assegnato allo spettatore. Come afferma Sandro Bernardi, "paesaggio significa non solo rapporto fra personaggio e spazio, fra uomo e mondo, ma anche rapporto fra diversi livelli di sguardo; c'è l'osservatore, che è un personaggio, e la cinepresa, che osserva l'osservatore [...]. Dietro l'osservatore e dietro la cinepresa però un altro sguardo sta in aggua-to, nell'ombra, quello dello spettatore, che organizza e struttura il suo rapporto con il film secondo codici e modelli culturali sempre diversi". In altre parole, il dato scenografico si struttura attorno a tre diverse esperienze visive – lo sguardo dei personaggi dentro il film, lo sguardo del film, lo sguardo dello spettatore sul film – che trovano nella dimensione del viaggio il loro denominatore comune. Chiunque sia colui che osserva il paesaggio (protagonista, regista o spettatore), occorre che assommi al ruolo di voyeur anche quello di voyageur. Senza il movimento – interno al film – di un personaggio, di un'automobile o di un treno, o – esterno alla diegesi – di una panoramica o di un dolly, il paesaggio non potrebbe avere centralità espressiva. Tuttavia se spostarsi nello spazio diventa azione indispensabile per catturare più "realtà" possibile, ne sancisce, allo stesso tempo, l'illusorietà dell'atto: come avviene in un sogno (quello che si appresta a fare Puya una volta entrato nella galleria) lo spettatore "visita" territori nuovi senza muoversi dalla propria poltrona. In tal senso, si prefigura come essenziale all'analisi filmica non tanto la fisicità del movimento, quanto la capacità di assegnare sempre nuovi significati al movimento stesso. È ciò che tenta di fare il cinema iraniano sfruttando la ricchezza topografica del proprio territorio non solo per rendere affascinante ogni singola inquadratura, ma per gremirla di contenuti e piani di lettura. Ed è ciò che, in seconda battuta, si propone di compiere questo studio, attuando una sorta di "semantica" del paesaggio, ovvero di decodifica dei vari significati che ha assunto il contesto ambientale nell'opera di quei cineasti iraniani che, negli ultimi vent'anni, si sono fatti conoscere dal pubblico di tutto il mondo. Il naufragio Un caso analogo avviene in Acqua, vento, terra di Amir Nâderi. La pellicola citata narra la storia di un ragazzo che vuole ritrovare i propri genitori nonostante questi ultimi lo abbiano abbandonato ancora neonato. La regione dove vivono è deserta, colpita da una siccità che costringe i suoi abitanti a fuggire, spazzata via da un vento che non arresta mai la sua furia, ma che, anzi, solleva in aria polvere e terra. Mentre fantasmi ricoperti di sabbia (anche in questo caso dunque gli uomini sono ridotti a incorporei simulacri) scappano da quel territorio secco e senz'acqua, il ragazzino segue un itinerario letteralmente "controcorrente". Egli sembra essere un novello Noè, costretto a sopravvivere ad una punizione divina che intende cancellare dal mondo ogni traccia umana prima di riportare la vita sul pianeta. Lo conferma una delle sequenze più intense, lancinanti ed espressive del film. Nel corso della sua faticosa ricerca, il ragazzo si imbatte in un neonato abbandonato, evidentemente un suo doppio. Cosciente di non poterlo accudire, obbligato quindi a ripetere, almeno in parte, lo stesso "peccato" originario commesso dai suoi genitori, lo disseta con un po' d'acqua (ne raccoglie dell'altra in un secchio e la posa accanto a lui) e lo abbandona sulla strada sperando che una famiglia, attirata dalla possibilità di dissetarsi, venga a prenderlo e lo porti con se. Nondimeno, quando un gruppo di persone transita per quella strada, il protagonista rivive, una seconda volta, il proprio "naufragio": quella famiglia non si prende cura del neonato (proiezione del protagonista), ma beve l'acqua del secchio e se ne va. Il ruolo dell'ambiente esterno è decisivo per rafforzare que-sta sensazione: in una sequenza costruita come fosse un film muto, nessuna parola viene pronuncia-ta perché non occorre aggiungere altri significati all'episodio, ci sono solo gesti resi faticosi dalle avverse condizioni meteorologiche e un vento che alza nuvole di sabbia e che nasconde, oltre alle sagome delle persone, ogni forma di umanità, trasformando gli uomini in animali, i genitori in infanticidi. Terra, vento, acqua, neve e – come risultato del loro movimento panteistico – siccità, tempesta, temporale, burrasca: è attorno alla fisicità del territorio e alla sua intima vitalità che si erige la funzione significante del paesaggio. La definizione di "naufragio" adottata da Arecco è convincente perché esprime quell'idea di dialettica degli equilibri che ogni movimento interno ad un'inquadratura produce. Il paesaggio, infatti, è il risultato di un sottile gioco di bilanciamenti tra i moti che "sconvolgono" l'immagine cinematografica: il movimento del territorio (terremoti, nevicate, tempeste di sabbia), quello dei personaggi (attraversamenti, immersione, staticità dell'eroe cine-matografico), quello della macchina da presa (dolly, panoramiche, zoom). È dal dialogo tra queste tre direttrici – dialogo che prevede anche l'assoluta paralisi di tutti e tre gli elementi, come dimo-strerà lo schermo nero di Il sapore della ciliegia di ‘Abbâs Kiârostami – che il contesto ambientale acquista una imprescindibile dimensione connotativa. L'umanizzazione del paesaggio Ma è nel cinema di ‘Abbâs Kiârostami che il paesaggio si fa vero e proprio alter ego dell'individuo, specchio che riflette la nudità di ogni uomo, e in particolare dell'artista. In Il vento ci porterà via, Farzhad, capo di una troupe televisiva che vuole documentare un funerale tradizionale che si celebra soltanto in un remoto villaggio curdo, scopre, giorno dopo giorno, che il suo soggiorno in quel villaggio è un'intima e personale occasione per scoprire l'autenticità e la limpidezza che alberga nell'animo umano. Gli immensi campi di grano, le piantagioni di fragole, la grotta dove scende a prendere il latte (anche il nero di una grotta, simbolo dell'utero materno, è per sua stessa essenza paesaggio), la collina del cimitero, sono luoghi che accolgono il personaggio e ne svelano, in un sol momento, la meschinità e la profonda umanità. Non a caso il film termina con l'inquadratura di un osso umano che, gettato da Farzhad nell'acqua, scende veloce lungo il ruscello (altro "territorio" in movimento): il gesto del protagonista è un evidente segno dell'immersione dell'uomo nel paesaggio, di fiducioso abbandono in una corrente che guida e protegge i passi dell'umanità. Il finale di Sotto gli ulivi è uno dei momenti più alti del cinema di Kiârostami. Tahereh sta tornando a casa dopo aver lavorato come comparsa in un film. Accanto a lei c'è Hossein, giovane figu-rante che ama la ragazza e la corteggia da qualche giorno. Egli attende, con una fiducia che rasenta l'illusione, che lei accetti la sua proposta di fidanzamento, ma Tahereh non si è ancora pronunciata. Mentre passeggiano sotto un verde uliveto, il ragazzo gioca le sue ultime carte per cercare di coronare il proprio sogno. Il sentiero che percorrono supera una collina e scende verso una valle rigogliosa. Una volta in cima al poggio però, la macchina da presa si arresta, non segue più i due giova-ni limitandosi ad osservarli mentre si allontanano. Quando ormai sono diventati, agli occhi dello spettatore, poco più che piccoli puntini immersi nella natura, un brano di musica classica inizia a ri-suonare allegro in sottofondo e suggerisce un probabile assenso della ragazza. "La musica di Cimarosa, leggermente allegra, dichiara quello che noi non possiamo intendere, lasciando ai personaggi il loro segreto: questo commento senza ipocrisia lascia misurare quello che la vita deve all'arte, perché senza di essa, il disvelamento avrebbe avuto la stessa chiarezza, ma sarebbe stato compreso dal-la ragione e non dal cuore. Hossein ritorna indietro di corsa quasi volesse affacciarsi davanti alla macchina da presa e informare lo spettatore del finale positivo, ma i titoli di coda interrompono la sua corsa e lo spettatore non saprà mai con certezza la risposta di Tahereh. Il paesaggio rimane il solo custode del segreto della coppia, la accoglie, la protegge, la esclude alla vista del pubblico ma anche dello stesso regista. Ne Il sapore della ciliegia ci troviamo di fronte ad un caso analogo an-che se contrario nell'esito. Un aspirante suicida, Badii, viaggia in macchina nella periferia di Tehe-ran alla ricerca di una persona disposta ad interrarlo, il giorno successivo alla sua morte. Il paesaggio che circonfonde Badii appare lo specchio della sua coscienza: brullo, morto, fatto di terra gialla, pieno di buche (dentro le quali continua a inciampare la sua vettura), di strade cieche e polverose, coperto da una vegetazione composta di pochi alberi e poche zone verdi, le case trasformate in pala-fitte senza fondamenta. I soli animali che il protagonista incontra nel suo viaggio sono corvi, funesti ambasciatori di morte. In una sequenza ambientata in una cava di terra , una ruspa sommerge il suicida mettendo in pratica (il sotterramento) ciò che il personaggio chiede di fare ai passanti che incontra. L'ambiente naturale procede nel suo percorso di umanizzazione, prolungando le azioni dell'eroe cinematografico e trasformandosi, di conseguenza, in un nuovo soggetto demiurgico simi-le a quello del regista. Da questa prospettiva, l'ambiente non è soltanto il luogo fisico del naufragio, spazio nel quale le dinamiche e i conflitti narrativi in atto deflagrano violentemente, ma è anche ap-prodo del naufrago, entità terza che vive (quasi) indipendentemente da un metteur en scène che lo riprenda e lo riproduca attraverso l'occhio della macchina da presa. Nel momento in cui Kiârostami affida i suoi personaggi all'ambiente (avviene nei finali di E la vita continua, Sotto gli ulivi, Il sapore della ciliegia), non solo annulla la propria funzione di autore, ma crea un cortocircuito dentro il quale il paesaggio fittizio del cinema si trasfigura in paesaggio reale, concreto. La macchina da presa arresta la sua azione. Rimane la natura. Essa esisterà indipendentemente da una sua (eventuale, a questo punto) raffigurazione cinematografica o fotografica. La fallibilità dell'occhio "La vista perse la strada" Preghiera, Sohrâb Sepehri L'esegesi del paesaggio cinematografico è, tuttavia, correlata alle logiche dello sguardo, alla base delle quali, nel cinema come nelle altre arti figurative, si situa ogni processo creativo. Il punto di vista, l'osservatore, l'atto dell'osservare, il tipo di focale con cui riprendere un dato oggetto sono elementi altrettanto importanti della materia da riprendere. Riflettere sulle problematiche dello sguardo equivale pertanto a riflettere sull'essenza stessa del cinema e, dunque, a vertere la propria ricerca anche su un piano metalinguistico. Se il cinema iraniano degli ultimi decenni ha trasformato il metacinema in uno dei suoi temi più ricorrenti, probabilmente la ragione è da ricercare nei limiti che la "decima musa" manifesta, in particolar modo sul versante realistico della rappresentazione. Film molto diversi tra loro sono accomunati dalla convinzione che l'occhio della cinepresa (e di conseguenza quello del regista) sia fallibile, incapace ad esprimere l'eterogeneità dell'esperienza fenomenica. Nel già citato Il vento ci porterà via, ad esempio, il protagonista Farzhad compie il proprio viaggio di scoperta e di immersione nel paesaggio solo dopo aver rinunciato al più impor-tante (cinematograficamente parlando) dei cinque sensi, la vista: abbandona la macchina fotografica ad un bar (una versione meccanica dell'occhio), parla con uno scavatore senza riuscire a vederlo in faccia (l'uomo parla con Farzhad mentre scava un pozzo), ascolta una poesia all'interno di una grot-ta buia. Alla fine del film Farzhad avrà rinunciato al "positivismo" dell'occhio, a quella fiducia (tipicamente occidentale) nell'efficacia assoluta dei sensi. In Lo specchio assistiamo ad un ribaltamento dell'espediente sin qui descritto, determinato dalla rottura del gioco della finzione. Nella seconda parte del film, il corpo della bambina sparisce letteralmente alla vista dello spettatore, co-perto da persone, vetture, altri oggetti. La fallibilità dell'occhio concerne non più il personaggio ma la macchina da presa, mostrando i limiti del pedinamento zavattiniano, e nel contempo l'impossibilità di scegliere altri modelli di rappresentazione del reale. Rimane il frenetico e vorticoso paesaggio della città, i fumi, i clacson, lo stress e il delirio che ne scaturisce. In entrambi i film – ma potremmo citare anche Il silenzio di Mohsen Makhmalbâf, storia di un giovane accordatore di strumenti musicali cieco – la sconfitta dello sguardo statuisce una diversa natura del viaggio e di conseguenza una diversa natura del paesaggio. Nel momento in cui l'itinerario dell'osservatore si trasforma nell'itinerario di un cieco anche il territorio perde la sua dimensione fisica per assumerne una "metafisica", da oggetto da osservare si trasforma in effigie da immaginare. L'esempio più lampante arriva, ancora una volta, da un film di Kiârostami. In Dov'è la casa del mio amico il piccolo Ahmad cerca per buona parte del film il domicilio di un suo compagno di classe per restituirgli un quaderno. Quando arriva finalmente davanti alla casa, dopo tante faticose peripezie, la notte è calata e si scorge a fatica tra le tenebre la figura di Ahmad. Anche la casa è buia, solo la porta illuminata. Nel buio avviene il colpo di scena: il ragazzo invece di entrare nella, torna sui suoi passi e abbandona la ricerca. Le domande restano senza risposta: la casa non è quella dell'amico? Ahmad ha paura e non osa entrare in quell'abitazione? Ha cambiato idea all'ultimo? Quel che rimane è la rimozione fisica di un luogo tanto agognato e l'obbligo, da parte del pubblico, di immaginarsi una ragione della scelta e costruirsi un proprio paesaggio. Anche la terra che dovrebbe accogliere il suicida Badii rimane in un simbolico fuoricampo. Al termine di Il sapore della ciliegia, un film che – come accennato poco sopra – ha nel territorio uno specchio fedele dello scoramento del protagonista, l'uomo si sdraia per terra in attesa che la morte lo colga. La cinepresa lo inquadra in primo piano e poi riprende, come soggettiva del protagonista, le nuvole e la luna. Non c'è più spazio per una panoramica o una carrellata che apra sul paesaggio. Laddove fallisce la vista, la presenza del contesto ambientale si sposta, pertanto, dal "battere" al "levare" (dal campo al fuori campo), senza che questo mutamento di funzioni ne metta in dubbio la centralità del ruolo all'interno dello spartito filmico. Anzi, come avviene nei film di Kiârostami ma non solo, tale "sottrazione" paesaggistica finisce per essere un altro modo per attribuire significazione al dato empirico. Un finale (aperto): l'eco del paesaggio Filmografia di riferimento Bibliografia essenziale Cinema e Paesaggio Cinema Iraniano Monografie di registi iraniani Articoli di riviste Note Per comodità e per facilità di lettura, abbiamo deciso di inserire nel testo del saggio solo il titolo italiano e il regista delle pellicole citate. Per riferimenti più puntuali (titolo originale, anno di produzione) rinviamo alla filmografia presente in coda al testo. Nel caso di E la vita continua questo moto di accettazione e rifiuto del paesaggio serve per creare distacco tra realtà e rappresentazione (un distacco non freddo ma partecipato), in modo da evitare i facili sentimentalismi da una parte e le incaute immersioni nei dolori intimi delle persone (che il regista giudica profondamente immorali) dall'altra. Nessun sensazionalismo, né tv-verità, ma solo una riflessione teorica e quasi estatica sulla forza di sopravvivenza dell'uomo. S. Bernardi, Il paesaggio nel cinema italiano, Marsilio, (Venezia, 2002), 23. Della produzione iraniana prenderemo in esame, quindi, solo i film "d'arte" ovvero quelle opere che hanno ottenuto i maggiori riconoscimenti di critica in Occidente, che sono stati presentati nei festival o distribuiti nelle sale italiane e che, di conseguenza, hanno fatto conoscere il cinema iraniano nel mondo. Pur essendo film d'elite, sicuramente tra i meno visti dagli spettatori iraniani, essi rappresentano la parte più sperimentale, innovativa e interessante di una cinematogra-fia altrimenti di livello medio basso. Oltre a Kiarostami, verranno citate le opere di maestri del cinema iraniano degli anni 70-80 come Beizai, Naderi, e Mohsen Makhmalbaf e della nuova generazione di cineasti (Panahi, Ghobadi, Samira Makhmalbaf, Yekpatanah, Payami). Verranno perciò, ahinoi, esclusi dall'analisi autori fondamentali nella storia del cinema persiano che però sono quasi del tutto sconosciuti al pubblico (cinefilo) mondiale. Si tratta di Daryush Mehrju'i, Parviz Kimiavi, Kianush Ayyari, e dei più giovani Abolfazl Salili, Majid Madidi. Tra i tanti articoli si veda B. Nichols, "Discovering form, inferring meaning: new cinemas and the film festival circuit", Film Quaterly, 47 (Spring 1994), 16-31. Ci venga perdonato dai puristi del genere questo parallelo tanto azzardato quanto, a nostro avviso, calzante. S. Arecco, Il paesaggio del cinema, Le Mani (Recco, Ge, 2001), 12-13. Amir Naderi è uno dei registi più importanti e più radicali della nouvelle vague iraniana degli anni '70/'80. Oltre a Acqua, vento, terra e Il corridore, i suoi film più conosciuti, ha girato in patria gli altrettanto belli Addio amico (Khoda-hafez rafigh 1971) e Tangsir, (Id, 1974). Dai primi anni novanta si è trasferito a New York e qui opera, tra mille difficoltà, come filmmaker indipendente. Suoi sono Manhattan by numbers (1993), A,B,C... Manhattan (1997), e Marathon (2002). Il finale della pellicola che, sulle note della Quinta di Beethoven, mostra il protagonista mentre scava a mani nude numerose buche nella terra fin quando non trova l'acqua, ha i tratti dell'epopea biblica. I pesci riprendono vita, l'acqua sgorga come fonte di vita, il film si conclude con un segno di speranza che mai Naderi, nel corso del racconto, aveva, anche lontanamente, suggerito. Avremo modo di parlare di questo film poco più avanti. La citazione si riferisce all'ultima sequenza della pellicola che si conclude con un minuto di schermo nero: paesaggio, personaggio, macchina da presa, regista, spettatore vengono inghiottiti dal nero dell'immagine, simbolo di un autodafè che coglie ogni individuo di fronte alla morte. Il film narra, infatti, la storia di un aspirante suicida e l'epilogo dovrebbe mostrare (ma non lo fa) l'estremo atto del protagonista. Il racconto a focalizzazione interna prevede che il narratore assuma il punto di vista di un personaggio, mostrando solamente ciò che egli può sapere. Il riferimento è ovviamente a Il ragazzo selvaggio di François Truffaut. A. Barbera, U. Mosca, Mohsen Makhmalbaf, Lindau, (Torino, 1996), 144. Si tratta di E la vita continua. Per un'analisi del fitto gioco di rimandi e relazioni tra Dov'è la casa del mio amico, E la vita continua, e Sotto gli ulivi – comunemente conosciuta come "La trilogia di Kokér" – rinvio a M. Dalla Gassa, Abbas Kiarostami, Le Mani (Recco, 2001), 67-117. A. Masson, "Au travers des oliviers: La répétition ou l'amour récompensé", Positif, 408 (1995) 6-8. Per un'analisi linguistica della sequenza rinvio a Dalla Gassa, Abbas Kiarostami, 177 ss. Annullarsi come regista è una delle più grandi e innovative ossessioni kiarostamiane. L'ultimo film Dieci, ad esempio, è girato tutto all'interno dell'abitacolo di una macchina, con due sole inquadrature che riprendono il guidatore e il passeggero dell'auto. Togliendo al regista la "sovranità" del montaggio e della scelta delle inquadrature, nonché dei movimenti di macchina e dei dialoghi (la sceneggiatura del film era, in origine, poco più che un canovaccio), Kiarostami ridisegna la figura del cineasta, decantandolo (nella doppia accezione di purificare e lodare). Per un approfondimento si veda P. Blouin, C. Tesson, "Elimination de l'auteur", Cahiers du cinéma (septembre 2002), 12-20. Ecco alcuni titoli che "mettono in scena" il cinema e che non citiamo nel testo: Close up, E la vita continua, Sotto gli ulivi e ABC Africa di Kiarostami, Salaam cinema, C'era una volta il cinema e Pane e Fiore di Mohsen Makhmalbaf, Lo specchio di Jafar Panahi, La mela di Samira Makhmalbaf. Lo spechio racconta la storia di una ragazzina che, stufa di recitare in un film la parte di una studentessa sola e abbandonata, rompe il gioco della finzione, lascia il set e ritorna a casa. Il regista Panahi, per non perdere la possibilità di terminare il proprio film, decide di inseguirla, con un operatore affianco, per le vie caotiche della città; tuttavia il lavoro di pedinamento si rivelerà molto più complesso di quello meramente cinematografico, visto che la protagonista non solo riesce a sfuggire all'occhio della cinepresa ma perché, una volta giunta a casa, si rifiuterà di far entrare, tra le mura domestiche, il regista, lasciandolo sconsolatamente privo di un finale. |
Marco Dalla Gassa
in AA.VV. Miscellanea di studi in onore di Adriano Alpago Novello,
in corso di pubblicazione presso la casa editrice Civis di Napoli