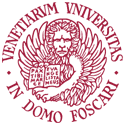Opinioni sul corso e occupazione
Indagine Almalaurea 2025
AlmaLaurea è un Consorzio interuniversitario che ha tra i propri obiettivi principali quello di facilitare e migliorare l’ingresso e la collocazione nel mondo del lavoro nonché quello di agevolare le aziende nella ricerca del personale qualificato. Il Consorzio raccoglie inoltre dai laureati e dalle laureate informazioni sulla loro condizione occupazionale e valutazioni sul percorso di studi svolto.
Valutazione del corso
Leggi come valutano il corso gli studenti e le studentesse che lo frequentano; puoi trovare le loro opinioni sull'attivita' didattica e sulla docenza e sul docente ma anche sui servizi, l'organizzazione del corso, le attrezzature didattiche dell'Ateneo; le valutazioni vengono raccolte in un questionario on line che ciascun iscritto e iscritta compila al termine di ogni insegnamento.
|
|
Questionario didattica del Corso di Laurea Magistrale
I dati all'interno del file riguardano il Corso di studio corrispondente nell'offerta formativa dei precedenti anni accademici. |
257 KB |
|
|
Questionario didattica e servizi di Ateneo
I dati all'interno del file riguardano il Corso di studio corrispondente nell'offerta formativa dei precedenti anni accademici. |
386 KB |
Perché Ca' Foscari
Le motivazioni degli immatricolati e delle immatricolate alle lauree triennali e magistrali di Ca' Foscari raccolte in una indagine in cui chi si immatricola spiega i motivi per cui ha scelto l'Ateneo veneziano.
|
|
Questionario immatricolati e immatricolate
I dati all'interno del file riguardano il Corso di studio corrispondente nell'offerta formativa dei precedenti anni accademici. |
666 KB |
Lo stage valutato dagli studenti e dalle studentesse e dalle aziende
Leggi le opinioni delle aziende e degli studenti e delle studentesse cafoscarini al termine dello stage. Puoi trovare informazioni e consigli interessanti su come affrontare questa esperienza.
|
|
Questionario stage - marzo 2025
I dati all'interno del file riguardano il Corso di studio corrispondente nell'offerta formativa dei precedenti anni accademici. |
237 KB |
I nostri laureati nel mondo

Tae Cimarosti
Ci sono incontri che sanno trasformarsi in veri snodi di vita, momenti in cui percorsi lineari e prevedibili si aprono a direzioni inattese. Per me, l’incontro con l’antropologia è stato questo — e molto di più.
Era un caldo pomeriggio d’ottobre e l’aula era gremita di studenti. Il corso di Introduzione all’Antropologia era una tappa obbligata del nostro piano di studi in Conservazione e Gestione dei Beni Culturali e molti di noi non avevano idea di cosa fosse l’antropologia, né di cosa aspettarsi dalla lezione. Eppure, quando il professore presentò i principali temi e (s)oggetti di studio della disciplina, vi riconobbi molto della mia esperienza personale: una vita trascorsa tra due culture, italiana e giapponese, e una persistente fascinazione per gli spazi liminali. Proseguii con il corso di Introduzione all’Antropologia (Approfondimenti) e mi accorsi che leggere etnografie, e ancor più dialogare con antropologi e appassionati della materia, mi dava energia ed entusiasmo. Più imparavo, più cresceva il desiderio di capire.
L’iscrizione al corso magistrale ACEL fu quindi una scelta naturale. Qui incontrai docenti e colleghi animati da una passione intensa e contagiosa. Pur provenendo da interessi e percorsi diversi, tutti condividevano — attraverso l’antropologia — un terreno comune, capace di mettere in dialogo prospettive differenti. Con il sostegno di una borsa della Fondazione Benetton, trascorsi sei mesi di ricerca sul campo ad Arahama, nel nord-est del Giappone. Questo piccolo distretto costiero era stato completamente spazzato via dallo tsunami del 2011 e i suoi residenti erano stati rilocati altrove. Dove un tempo sorgevano case e memorie radicate, erano stati costruiti parchi sportivi e ristoranti. La mia ricerca mirava a capire come, dietro all’etichetta di “terra abbandonata” diffusa dalla municipalità, si celassero invece gli sforzi dei residenti per reinventare e mantenere viva la relazione con quella che per loro rimaneva “casa”: nonostante il disastro, l’assenza e la distanza.
Scrivendo la tesi, mi avvicinai al lavoro di un antropologo che aveva affrontato tematiche affini alle mie e decisi che avrei voluto collaborare con lui. Presentai una candidatura con l’obiettivo di ampliare la ricerca sviluppata nel percorso magistrale e ottenni una borsa di dottorato in antropologia alla Princeton University, comprensiva di visto, tasse, stipendio, assicurazione sanitaria e, soprattutto, la possibilità di lavorare con l’antropologo il cui lavoro mi aveva così profondamente influenzata. Il dottorato mi ha permesso di co-insegnare un corso di Antropologia dei disastri a studenti triennali di Princeton e Introduzione alla cultura giapponese contemporanea in collaborazione con la Tokyo University; di presentare la mia ricerca agli incontri annuali dell’American Anthropological Association; di accompagnare studenti e dottorandi in Giappone nell’ambito del Princeton Institute for International and Regional Studies; di condurre ricerca ai National Archives and Records Administration (USA), alla National Diet Library (Giappone) e di realizzare tre ulteriori fieldwork ad Arahama. Attualmente sto portando avanti un lavoro sul campo di almeno tredici mesi, che sarà alla base della mia tesi di dottorato, sostenuto anche da una posizione di visiting researcher presso l’International Research Institute of Disaster Science della Tohoku University.
Da Arahama ripenso oggi a quel pomeriggio d’ottobre, a come ACEL abbia posto le fondamenta del mio percorso, ampliato i miei orizzonti e contribuito a renderli concreti. E a come molti docenti, colleghi e alumni siano diventati amici e antropologi dai quali non ho mai smesso di imparare.

Yosri Razgui
Il mio primo incontro con l’antropologia risale al secondo anno del corso di laurea triennale in lingua giapponese (LICSAAM - Ca’ Foscari, Venezia). Il corso di laurea offriva la possibilità di integrare il curriculum scegliendo tra vari indirizzi, tra cui quello demo-etno-antropologico. Ho subito trovato nell’antropologia culturale una disciplina estremamente illuminante che, oltre a far luce su vari aspetti del comportamento sociale umano, ha rappresentato per me una sorta di cassetta degli attrezzi interpretativa, offrendomi strumenti per comprendere la mia “multiculturalità”. Nato e cresciuto in Italia da genitori tunisini, erano numerosi gli interrogativi identitari che sono emersi nel tempo negoziando tra due realtà culturali molto diverse. L’antropologia culturale mi ha aiutato a definire meglio questi quesiti, fornendomi utilissimi strumenti teorici per affrontarli.
Nel 2015, ho deciso di approfondire la materia iscrivendomi al corso di laurea magistrale ACEL (Antropologia Culturale, Etnologia, Etnolinguistica), convinto che l’antropologia potesse essere il perfetto punto d’incontro tra i miei principali interessi di quegli anni: il calcio e il Giappone. Durante il secondo anno ho potuto trascorrere dieci mesi all’Università di Kobe grazie al programma di mobilità Overseas, esperienza che mi ha anche permesso di svolgere la ricerca sul campo necessaria per la stesura della tesi magistrale. Il progetto proponeva un’analisi comparativa della partita di calcio contemporanea giapponese, indagandone le funzioni rituali e il grado di anti-strutturalità. Durante il fieldwork, durato sei mesi, sono entrato in contatto con il principale gruppo di tifosi del Vissel Kobe (club calcistico professionale), grazie al quale ho potuto svolgere osservazione partecipante e raccogliere dati qualitativi di prima mano. In seguito al fieldwork, ho avuto l’opportunità di partecipare al programma Erasmus e trascorrere nove mesi presso l’Università Lumière Lyon 2, dove ho condotto ulteriori ricerche per la tesi e seguito corsi presso il Dipartimento di Antropologia.
Dopo la laurea magistrale, conseguita nel 2019, grazie all’ottenimento di una borsa di ricerca del Ministero dell’Istruzione giapponese (MEXT), ho avuto accesso al corso di dottorato presso l’Università di Kobe. In quel periodo ho potuto approfondire la mia ricerca sui tifosi del Vissel Kobe, rafforzando al contempo la base teorica e la profondità dell’analisi finale. La ricerca di dottorato ha messo in luce il forte nesso simbolico tra i valori del capitalismo neoliberista e il comportamento rituale dei tifosi di calcio in Giappone, dimostrando come le componenti rituali di un gioco globale come il calcio possano essere simbolizzate in modo diverso a seconda dei valori strutturalmente egemoni del contesto socioculturale di riferimento.
Dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (2024), sono stato assunto inizialmente come ricercatore a contratto presso l’Università di Kobe, con l’obiettivo di estendere la mia precedente ricerca ad altre aree geografiche del Giappone, e successivamente come Project Assistant Professor. In questo ruolo ho avuto anche la possibilità di insegnare materie affini all’antropologia culturale (Metodologia della ricerca qualitativa e Studi culturali sul Giappone).

Lorena Cavuoti
Nel mio percorso di formazione, mi sono imbattuta nell’antropologia più per accidente che per proposito: anche più significativamente per questo, il dialogo che ne è derivato è diventato nel tempo sempre più definitivo.
Da studentessa di letterature comparate, ero sospinta nel mio studium dal desiderio di tracciare la genealogia emotiva di una certa passione verso il racconto breve che da sempre avevo cercato sia nel letterario sia nel quotidiano – ne ero rimasta catturata dopo l’incontro con la voce di Gertrude Stein in Melanctha, che era diventato per me cadenza di sforzi e immaginazioni. In seno a questo progetto di formazione era venuto a calarsi, per l’appunto fortuitamente, un corso di antropologia, che avevo deciso di seguire per irrobustire le posizioni da cui guardavo alle cose: al contrario, nasceva in me l’intuizione che la postura che più mi sarebbe riuscita congeniale per esplorare il mondo del racconto non fosse tanto quella letteraria quanto quella antropologica.
In linea con questo, mi sono iscritta alla magistrale in ACEL di Ca’ Foscari nel novembre del 2020. Ho frequentato i corsi proposti con grande entusiasmo, costruendo man mano una rete di riferimenti, concetti, paradigmi sempre più estensiva. In particolare, è stato decisivo il momento in cui, tra lezioni e letture, sono venuta a incontrare per la prima volta le storie di vita: queste, portandomi a reinterpretare tutte daccapo le potenzialità creatrici di senso del racconto, mi hanno permesso nel tempo di entrare in dialogo con quanto di antropico c’è in quello fatto in seno alla ricerca antropologica. Con l’irrinunciabile supporto del mio relatore, sono andata costruendo a partire da lì la mia ricerca sul campo, che ho svolto nel 2022 nella Bay Area, in California centro-settentrionale, nel tentativo di allinearmi con l’esplorazione della frontiera tra Messico e Stati Uniti per come incorporata e narrata dall’individuo che ne fa esperienza.
La decisione di proseguire con un programma di dottorato si è rivelata l’esito più naturale. Dopo la fruttuosa formazione a Ca’ Foscari, sono attualmente dottoranda nel programma di Sociología y Antropología dell’Universidad Complutense de Madrid, dove la sintonizzazione con dibattiti e convegni internazionali e l’insegnamento in ambito universitario vanno contribuendo significativamente ad arricchire la mia ricerca. In continuità con le riflessioni sul portato epistemologico delle storie di vita iniziate in germe durante la triennale e latamente approfondite in magistrale così come con l’esplorazione dei significati emici di Latino community in contesto statunitense, mi dedico allo studio dell’esperienza emotiva e narrata del senso di belonging per come può conseguire dalle adesioni plurali a transnazionali contesti socio-culturali da parte dell’individuo migrante. Più in particolare, in sintonia con il metodo biografico, guardo alle dinamiche di ritorno dagli Stati Uniti a Città del Messico, presso cui sto attualmente svolgendo la mia ricerca sul campo.

Giulia Tongiani
Ho incontrato per la prima volta l’Antropologia a quattordici anni in un modo piuttosto non convenzionale. Leggendo l’ultimo capitolo di un manga sono rimasta folgorata dalle parole di un personaggio che sognava di fare l’antropologa per scoprire i “colori dei luoghi” entrando in contatto con chi quei luoghi li abita.
Negli anni ho esplorato varie strade, ma sono sempre tornata all’Antropologia, finendo per iscrivermi nel 2016 alla Laurea Triennaele in Storia a Ca’ Foscari e scegliere il curriculum Antropologico . Se la curiosità verso i ‘colori dei luoghi’ mi aveva avvicinato all’Antropologia, il mio percorso tirennale mi ha permesso di iniziare a scoprire l’incredibile varietà della disciplina e la sua capacità di guardare alla complessità della realtà attraverso l’incontro con gli altri, siano essi vicini o lontani.
Nel 2019, ho deciso di proseguire percorso intrapreso iscrivendomi al Corso di Laurea Magistrale in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (ACEL) . Consentendomi di muovermi tra due atenei, ACEL mi ha dato la possibilità di espandere e approfondire le mie curiosità e mettermi in gioco sia attraverso brevi esperienze di ricerca sia il dialogo con antropologi ed esperti di altre discipline italiani e internazionali. Nonostante la pandemia di COVID-19 ho potuto seguire i corsi in un’università statunitense grazie alla possibilità di compiere un Overseas da remoto, confrontandomi con una realtà educativa ben diversa da quella a cui ero abituata e mettendo in pratica la riflessività critica che il lavoro dell’antropologo richiede. Grazie a queste esperienze ho scoperto l’interesse per l’etnografia ‘at home’, ovvero per la ricerca ethnografica condotta nella propria società, e mi sono avvicinata all’ Etnografia dell’Educazione. Questo interesse si è tradotto nella la mia prima esperienza sul campo, per la tesi magistrale, durante la quale sono tornata per un semestre tra i banchi della scuola secondaria superiore per esplorare il rapporto degli adolescenti con la scuola.
Spinta della capacità dell’Antropologia di estendersi oltre i suoi confini e cercando la mia personale risposta alla domanda su come rappresentare gli studenti che avevano condiviso il loro tempo con me, mi sono avvicinata all’approccio dello student voice. Da quest’incontro fortuito con lo student voice è nato il progetto di ricerca sul rapporto studenti-insegnanti in Italia grazie al quale nel 2023 ho ottenuto la Presidential Scholarship presso l’Università di Southampton per un dottorato in Education. Al momento (2025) sono PhD Candidate con la possibilità di rimanere per un Postdoc e muovo passi sempre meno incerti nel mondo della ricerca in ambito educativo e nell’inclusione. Sebbene il mio progetto mi abbia portato ad allontarmene, l’Antropologia fa ormai parte di me e del modo in cui guardo al mondo dentro e fuori il mio lavoro. Grazie al mio percorso in a Ca’ Foscari e soprattutto in ACEL, l’Antropologia non è più la strada che ho scelto tra molte altre, ma il punto fisso e lo zaino da cui e con cui partire ed esplorare vecchi e nuovi percorsi.

Andrea Pia
A quindici anni di distanza, ho ancora un bellissimo ricordo della mia prima lezione di antropologia a Ca' Foscari. "I Bororo del Mato Grosso credono di essere arara, ovvero pappagalli rossi. Perché?". Quella domanda ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nella mia biografia intellettuale. E dire che all'antropologia ci sono arrivato quasi per sbaglio.
Dopo la laurea triennale in Lingue e Culture dell'Asia Orientale e un periodo di studi a Pechino, sentivo che la curiosità che mi aveva spinto a dedicarmi a una lingua tonale e ideografica, e a viaggiare in luoghi lontani, non si era ancora esaurita. Per la mia tesi magistrale in antropologia, decisi di trascorrere sei mesi in un villaggio rurale nelle montagne a ovest di Pechino.
Quella prima esperienza sul campo, che oggi rivivo con i miei studenti di master a Londra attraverso l'uso di un'etnografia digitale da me ideata, mi ha fatto prendere coscienza del preoccupante processo di degradazione ecologica e delle sue conseguenze sociali, come spopolamento e migrazioni forzate, temi che spesso sentiamo menzionare quando si parla di inquinamento in Cina e di crisi climatica.
Dopo la laurea magistrale, ho svolto un periodo di tirocinio all'Ambasciata di Pechino e ho lavorato come traduttore. Grazie a una borsa di studio, mi sono poi trasferito a Londra dove ho conseguito un master e un dottorato di ricerca alla London School of Economics (LSE), istituto in cui ora insegno e faccio ricerca come Professore Associato in antropologia. Il dottorato mi ha permesso di tornare in Cina per un periodo prolungato e di approfondire gli stessi problemi ambientali che avevo studiato per la tesi a Ca' Foscari.
Il mio lavoro attuale eredita l'attitudine inquisitiva, comparativa e riflessiva che aleggiava a San Trovaso quindici anni fa. Oggi, le domande che mi pongo non riguardano più uomini che si credono pappagalli, ma piuttosto politici o ingegneri cinesi che ritengono di poter salvare il proprio paese da una crisi climatica globale attraverso soluzioni puramente tecniche.
L'antropologia, da Ca' Foscari alla LSE, insegna che solo sfidando la nostra immaginazione attraverso domande e contesti insoliti possiamo affrontare le sfide ambientali, migratorie, energetiche e politiche del nuovo millennio. Come antropologo, oggi scrivo di Cina, stato, società civile e acqua su riviste specialistiche e non, rivolgendomi a un pubblico variegato. Il sito Made in China Journal è uno dei luoghi dove potete approfondire questi temi.

Valentina Scazzola
Il mio percorso accademico coniuga l’antropologia culturale con la museologia e la curatela, sviluppando un interesse specifico per i processi di rappresentazione, patrimonializzazione e restituzione dei beni culturali. Dopo la laurea triennale in Culture e Civiltà Orientali presso l’Università di Bologna, ho conseguito la laurea magistrale in Antropologia culturale, etnologia ed etnolinguistica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, con una tesi che ha unito ricerca etnografica e sperimentazione curatoriale.
Una delle esperienze più significative di questo periodo è stata la collaborazione con il Museo delle Culture del Mondo di Genova, dove ho svolto tirocinio e attività di ricerca in parallelo al mio lavoro sul campo in Perù. Lo studio delle collezioni tessili del museo e l’osservazione delle loro modalità espositive mi hanno permesso di mettere in dialogo i dati etnografici raccolti nella campagna di Cusco – vivendo a stretto contatto con una famiglia dove si pratica l’arte tessile – con le pratiche curatoriali. Da questo confronto è nato un prototipo espositivo, tuttora in fase di sviluppo, che traduce la ricerca antropologica in narrazione museale.
Parallelamente, ho potuto approfondire la mia formazione presso il Museo delle Civiltà di Roma, dove ho lavorato sui tessili precolombiani nei depositi e ho contribuito alle attività legate al nuovo allestimento delle collezioni, tuttora in corso, con particolare attenzione alle questioni di provenance e all’antropologia degli oggetti, analizzata attraverso seconda ricerca sul campo in Perù, che ha ampliato la mia prospettiva di confronto tra pratiche vive e materiali musealizzati.
Infine, la partecipazione al progetto internazionale Aboriginal Archives in Italy con l’università UTS (University of Technology Sydney) mi ha permesso di riflettere in maniera più approfondita sul linguaggio degli archivi e sulle strategie digitali per rendere accessibili i saperi in chiave interculturale.
La mia formazione si è arricchita attraverso corsi specialistici in antropologia museale, antropologia urbana e visual storytelling, oltre che con attività di ricerca e collaborazione editoriale.
Attualmente frequento la Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici presso la Sapienza di Roma e partecipo a progetti di riallestimento museale, digitalizzazione delle collezioni e mediazione con associazioni migranti.
Contemporaneamente sto per iniziare il Master Curating Cultures alla SOAS University of London, sostenuto dal Recognition Award dell’Ateneo: un’opportunità che mi permette di proseguire in un contesto internazionale la ricerca di un connubio tra curatela, antropologia, decolonizzazione e provenance, elementi che costituiscono il filo conduttore del mio percorso.