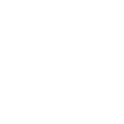STORIA DELLA LINGUA GRECA
- Anno accademico
- 2025/2026 Programmi anni precedenti
- Titolo corso in inglese
- HISTORY OF ANCIENT GREEK LANGUAGE
- Codice insegnamento
- FT0430 (AF:508296 AR:328831)
- Lingua di insegnamento
- Italiano
- Modalità
- In presenza
- Crediti formativi universitari
- 6
- Livello laurea
- Laurea
- Settore scientifico disciplinare
- L-FIL-LET/02
- Periodo
- 3° Periodo
- Anno corso
- 2
- Sede
- VENEZIA
- Spazio Moodle
- Link allo spazio del corso
Inquadramento dell'insegnamento nel percorso del corso di studio
Risultati di apprendimento attesi
Più in particolare, l'esito atteso è che le studentesse/gli studenti acquisiscano:
1) una conoscenza generale dell’evoluzione storica della lingua greca, dal II millennio all'età classica, alla luce dei fattori storico-geografici e rivolgendo particolare attenzione al rapporto fra dialetti epicorici e lingue letterarie;
2) una conoscenza di base delle principali lingue letterarie di età arcaico-classica e dei loro dialetti costitutivi;
3) una prima conoscenza dei testi documentari di età arcaica e classica;
4) la conoscenza teorico-metodologica delle problematiche relative alla linguistica storica del greco;
5) la conoscenza dei principali strumenti bibliografici (manuali di dialettologia e storia della lingua, dizionari etimologici) nonché dei principali sussidi elettronici (banche dati e dizionari online).
Prerequisiti
1) adeguata conoscenza del greco antico, certificata tramite maturità classica (o equivalente) o frequenza e superamento dei due moduli del corso Introduzione alla lingua greca;
Consigliati:
1) È utile, ma non obbligatorio, aver frequentato i corsi di Letteratura greca e di Epigrafia greca.
Contenuti
- la lingua della tragedia come testimonianza del dialetto attico;
- gli strati linguistici costitutivi della lingua della tragedia;
- il rapporto con la tradizione letteraria, in particolare con la lingua epica e il dorico della lirica;
- alcuni casi di mimesis linguistica in tragedia: la lingua degli oracoli, il linguaggio tecnico.
Testi di riferimento
A. C. Cassio (a c. di), Storia delle lingue letterarie greche, Milano, Mondadori, 2016 (NB seconda edizione): solo i capitoli 2 (La fonologia del greco e le sue radici indoeuropee, pp. 32-72) e 4 (Alfabeti locali, testi arcaici, edizioni ellenistiche, pp. 107-129).
V. Garulli – C. Neri, Morfologia e storia del greco antico, Roma, Carocci, 2024 (capp. 1-5, pp. 21-104).
La prima parte del corso spiegherà i fenomeni discussi in questi testi e fornirà suggerimenti su come affrontarli e integrarli tra loro.
B) La lingua della tragedia
S. Kaczko, "La tragedia", in A. C. Cassio (a c. di), Storia delle lingue letterarie greche, Milano, Mondadori, 2016, pp. 307-319.
Le lezioni introduttive alla lingua della tragedia illustreranno ulteriori studi recenti.
C) Testi:
La seconda parte del corso sarà dedicata alla lingua della tragedia, prima attraverso una sua descrizione nell’ambito delle lingue letterarie greche e alla luce delle caratteristiche tipiche dell’attico, e poi attraverso una selezione di testi, vòlti ad illustrare sia la varietà formale della tragedia (dialoghi, monologhi, sezioni corali), sia i diversi registri cui ricorrono i tragediografi maggiori. I testi sui quali ci eserciteremo, con commento e traduzione in classe, sono i seguenti (eventuali riduzioni saranno possibili alla luce del progresso fatto a lezione; il programma delle sezioni da portare all’esame verrà aggiornato a fine corso).
Euripide, Medea, vv. 214-266 (monologo)
Sofocle, Elettra, vv. 516-633 (dialogo)
Sofocle, Edipo Re, vv. 1222-1285 (rhesis del messaggero)
Eschilo, Agamennone, vv. 104-159 (sezione corale)
Per quanti non siano avvezzi al trimetro giambico saranno organizzate opportune esercitazioni di metrica. Per la sezione corale dell’Agamennone non è richiesta la lettura metrica. Un’introduzione al metro usato da Eschilo in questa sezione verrà fornita a lezione.
I testi su cui verterà il corso verranno forniti in forma di dispensa o materiali Moodle.
D) Letture di approfondimento (facoltative):
Per la storia della lingua:
A. Meillet, Lineamenti di storia della lingua greca, Torino, Einaudi, 1981 (seconda edizione italiana);
L. R. Palmer, The Greek Language, London, Faber, 1980;
O. Hoffmann – A. Debrunner – A. Scherer, Storia della lingua greca, Napoli, Macchiaroli, 1969.
Per la fonologia:
M. Lejeune, Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, Paris, Klincksieck, 1972.
Per la morfologia:
V. Garulli – C. Neri, Morfologia e storia del greco antico, Roma, Carocci, 2024.
Per la linguistica storica:
H. Rix, Historische Grammatik des Griechischen. Laut- und Formenlehre, Darmstadt 1992 (seconda edizione);
O. Szemerényi, Introduzione alla linguistica indoeuropea. A cura di G. Boccali – V. Brugnatelli – M. Negri, Milano, Unicopli, 1985.
Per la dialettologia greca:
Y. Duhoux, Introduzione alla dialettologia greca antica, Bari, Levante, 1986;
C. D. Buck, The Greek Dialects, Chicago, University of Chicago Press, 1955;
S. Colvin, A Historical Greek Reader, Oxford, OUP, 2007.
Modalità di verifica dell'apprendimento
1) domande relative all'introduzione generale e ai principi di fonologia e morfologia storica;
2) lettura (ove previsto, anche quella metrica), traduzione e commento linguistico di alcuni dei testi in programma.
Modalità di esame
Graduazione dei voti
Più in particolare:
- si considera sufficiente (18-22/30) la prova in cui la studentessa/lo studente sia in grado di rispondere, eventualmente anche grazie all'aiuto della docente, alle domande sui fenomeni generali di storia linguistica individuandone gli aspetti principali, con una sufficiente proprietà di linguaggio; di leggere in metrica (ove previsto), pur con qualche esitazione, e tradurre i testi greci con relativamente poche incertezze; e sia in grado di rispondere adeguatamente ad alcune delle domande sulla grammatica dei testi in esame (significati, paradigmi, declinazioni) e i fenomeni linguistici che essi contengono.
- si considera buona (22-26/30) la prova in cui la studentessa/lo studente sia in grado di rispondere autonomamente, senza bisogno di aiuto da parte della docente, con una adeguata proprietà di linguaggio, alle domande sui fenomeni generali di storia linguistica, individuandone gli aspetti principali, e fornendo una corretta descrizione storica e strutturale dei fenomeni; di leggere in metrica (ove previsto) e tradurre i testi greci con competenza, rispondendo correttamente ad un numero adeguato delle domande sulla grammatica dei testi in esame (significati, paradigmi, declinazioni) e ai fenomeni linguistici che essi contengono.
considera ottima (27-30/30) la prova in cui la studentessa/lo studente sia in grado rispondere autonomamente, senza bisogno di aiuto da parte della docente, e con ottima proprietà di linguaggio, alle domande sui fenomeni generali di storia linguistica, individuandone gli aspetti principali, fornendo una corretta descrizione storica e strutturale dei fenomeni, e proponendo collegamenti tra fenomeni diversi; di leggere in metrica (ove previsto) e tradurre i testi greci con competenza, rispondendo correttamente e senza esitazioni alla maggior parte delle domande sulla grammatica dei testi in esame (significati, paradigmi, declinazioni) e ai fenomeni linguistici che essi contengono.
- si considera eccellente (30/30 Lode) la prova in cui la studentessa/lo studente sia in grado di rispondere brillantemente, in italiano elegante e consono al contesto scientifico, alle domande sui fenomeni generali di storia linguistica, proponendo raffronti con altri fenomeni e/o fasi della lingua, strutturando la risposta in modo chiaro e attento ai collegamenti logici o strutturali tra i fenonemi; di leggere in metrica (ove previsto) senza alcuna esitazione e con fluidità, di tradurre i testi greci in modo elegante e attento alle sfumature stilistiche e lessicali del testo; di rispondere senza esitazioni a tutte le domande sulla grammatica dei testi in esame (significati, paradigmi, declinazioni) e ai fenomeni linguistici che essi contengono.