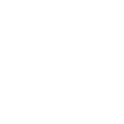HISTORY OF MEDIEVAL ART
- Anno accademico
- 2025/2026 Programmi anni precedenti
- Titolo corso in inglese
- HISTORY OF MEDIEVAL ART
- Codice insegnamento
- EM3A20 (AF:512434 AR:323572)
- Lingua di insegnamento
- Inglese
- Modalità
- In presenza
- Crediti formativi universitari
- 6
- Livello laurea
- Laurea magistrale (DM270)
- Settore scientifico disciplinare
- L-ART/01
- Periodo
- I Semestre
- Anno corso
- 2
- Spazio Moodle
- Link allo spazio del corso
Inquadramento dell'insegnamento nel percorso del corso di studio
Risultati di apprendimento attesi
1) Conoscenza approfondita degli oggetti medievali e del loro contesto originario (materiali, tecniche, funzioni, committenza, usi religiosi e sociali).
2) Capacità di analisi e contestualizzazione storico-artistica: interpretare le opere nel loro ambiente storico, politico, economico e culturale.
3) Consapevolezza critica della ricezione del Medioevo: comprendere come l’arte medievale sia stata riletta, collezionata ed esposta.
4) Conoscenza dei processi di musealizzazione e delle strategie espositive applicate all’arte medievale, inclusi i limiti e le problematiche etiche.
5) Conoscenza critica delle sfide curatoriali: comprendere le principali problematiche legate all’allestimento di mostre di arte medievale (ad esempio, decontestualizzazione, conservazione, leggibilità dei significati religiosi, narrazione museale, comunicazione al pubblico).
6) Abilità comunicative: descrivere in modo efficace e rigoroso un’opera d’arte.
Prerequisiti
Contenuti
PARTE I: Società, istituzioni e oggetti medievali
In questa prima fase verranno analizzati i principali attori, istituzioni e concetti che plasmarono la società medievale (istituzioni religiose e civili, committenza aristocratica e urbana, pratiche devozionali e culturali). Una volta acquisite le nozioni di contesto, si passerà all’analisi concreta degli oggetti prodotti durante il Medioevo (icone, reliqiuari, manoscritti, architettura, pittura, scultura), indagando il loro significato originario e la loro successiva ricezione.
PARTE II: Collezioni, musei e mostre di arte medievale
La seconda parte del corso sarà dedicata alla musealizzazione, alle collezioni e alle esposizioni dell’arte medievale. Verranno esaminati casi esemplari di collezioni, musei e mostre, con particolare attenzione alle sfide presentate dall’esposizione di oggetti di carattere devozionale: la decontestualizzazione, la perdita o trasformazione dei significati religiosi, le questioni conservative ed etiche, le strategie di comunicazione con il pubblico. In questo periodo le lezioni avranno una dimensione seminariale e includeranno la presentazione e la discussione in aula delle ricerche degli studenti. Il corso prevede, quando possibile, anche lezioni sul campo, in musei, collezioni o mostre dedicate all’arte medievale, e la partecipazione di conferenze di studiosi internazionali.
Testi di riferimento
- Kleiner, Fred S. Gardner’s Art through the Ages: A Global History. 13th ed. Cengage Learning, 2009, Intro; ch. 12-14 (pp.1-13; 347-442);
- Belting, Hans. Likeness and presence: a history of the image before the era of art. The University of Chicago Press, 1994, Intro; ch. 16-17 (pp. 1-15; 330-376);
- D. Freedberg, The Power of Images. Studies in the History and Theory of Response, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1989, ch. 1.;
- Montanari, Tomaso, and Vincenzo Trione. Contro le mostre. Einaudi, 2017. Ch. 1: Business Art (pp. 11-38);
- Brown, Michelle P. “The Modern Medieval Museum.” In A Companion to Medieval Art, edited by Rudolph Conrad. Blackwell, 2019 (pp. 957-976).
Aggiornamenti bibliografici concernenti le singole lezioni e/o i temi affrontati verranno forniti durante il corso.
Le lezioni in PDF saranno caricate nella piattaforma MOODLE.
Modalità di verifica dell'apprendimento
Si terrà conto della presenza, ma soprattutto della qualità dell’intervento degli studenti: capacità di porre domande pertinenti, formulare osservazioni critiche e collegare le letture assegnate agli argomenti trattati a lezione.
- Presentazione degli studenti (20%)
Ogni studente terrà una presentazione di circa quindici minuti, supportata da strumenti visivi, su un tema concordato con il docente. L’argomento potrà riguardare un’opera o un gruppo di opere medievali, un contesto di produzione, un episodio di collezionismo, un museo o una mostra. Saranno valutate la capacità di analisi, la chiarezza espositiva, l’uso del lessico storico-artistico e l’attitudine a gestire la discussione con i colleghi.
- Ricerca scritta individuale (30%)
Elaborato di massimo quindici cartelle (esclusi bibliografia e illustrazioni), da consegnare almeno quindici giorni prima dell’appello d’esame. Il lavoro dovrà includere un’introduzione, lo sviluppo dell’argomento con analisi critica di fonti e studi, una conclusione, una bibliografia articolata e un apparato iconografico con elenco delle illustrazioni. Verranno valutati la coerenza dell’argomentazione, la capacità critica, l’uso accurato della bibliografia, la correttezza formale e la chiarezza dello stile.
Norme redazionali: Times New Roman 12; spazio 1.5; note a piè di pagina secondo norme tesi. Illustrazioni a fine testo, con elenco illustrazioni. Bibliografia finale.
- Esame finale (40%)
L’esame verterà sui contenuti del corso, sulla bibliografia e sugli argomenti affrontati nelle lezioni e nelle presentazioni. Lo studente dovrà dimostrare una solida conoscenza delle opere medievali e dei loro contesti, la capacità di discutere questioni relative alla ricezione e alla musealizzazione, nonché l’uso appropriato del linguaggio specialistico. Durante l’esame sarà inoltre discussa la ricerca scritta individuale.
Modalità di esame
Graduazione dei voti
Presentazioni (20%)
Ricerca scritta individuale (30%)
Esame finale (40%)
Griglia di valutazione:
28-30L: padronanza degli argomenti trattati a lezione e nella bibliografia fornita; capacità di gerarchizzare le informazioni; uso della terminologia appropriata; l’esposizione orale è chiara, fluida e ben strutturata; la scrittura è corretta, scorrevole e rigorosa dal punto di vista metodologico.
26-27: buona conoscenza degli argomenti trattati a lezione e, in minor misura, nella bibliografia; discreta abilità nell'ordinare le informazioni e presentarle oralmente; familiarità con la terminologia tecnica; la scrittura è corretta e ordinata, ma può risultare meno articolata sul piano critico.
24-25: conoscenza non sempre approfondita degli argomenti trattati a lezione e nella bibliografia; esposizione orale ordinata ma con uso non sempre corretto della terminologia tecnica; la scrittura risulta comprensibile, ma piuttosto descrittiva e poco problematizzata.
22-23: conoscenza spesso superficiale degli argomenti trattati; esposizione orale poco chiara e carente sul piano della terminologia tecnica; la scrittura evidenzia debolezze nella costruzione logica e nella capacità di argomentazione.
18-21: conoscenza a tratti lacunosa degli argomenti trattati; esposizione orale confusa, con scarso ricorso alla terminologia tecnica; la scrittura è carente, con problemi di chiarezza, struttura e correttezza formale.