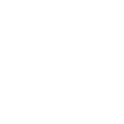LABORATORIO IN CAMPO
- Anno accademico
- 2025/2026 Programmi anni precedenti
- Titolo corso in inglese
- PRACTICAL ACTIVITIES IN FIELD
- Codice insegnamento
- CT0403 (AF:521804 AR:292962)
- Lingua di insegnamento
- Italiano
- Modalità
- In presenza
- Crediti formativi universitari
- 3
- Livello laurea
- Laurea
- Settore scientifico disciplinare
- NN
- Periodo
- Estivo
- Anno corso
- 2
- Sede
- VENEZIA
- Spazio Moodle
- Link allo spazio del corso
Inquadramento dell'insegnamento nel percorso del corso di studio
Le attività si svolgeranno a diretto contatto con diverse matrici ambientali - rocce, suoli, acqua, aria e organismi viventi - e con le interazioni tra questi elementi, in un’ottica multidisciplinare. Gli studenti saranno coinvolti in esperienze pratiche sul campo, che richiedono osservazione, campionamento, analisi e interpretazione dei dati ambientali.
Il corso intende promuovere un approccio integrato allo studio dell’ambiente, combinando saperi e metodologie proprie delle Scienze della Terra, della Chimica e dell’Ecologia animale e vegetale.
Risultati di apprendimento attesi
In particolare, lo studente:
• Comprenderà il significato e il valore di un approccio multidisciplinare allo studio dell’ambiente;
• Confronterà approcci scientifici diversi applicati a matrici ambientali reali (acqua, rocce, suolo, aria, biota);
• Imparerà a utilizzare tecniche di campionamento e analisi specifiche in situ;
• Sarà in grado di organizzare, analizzare e interpretare criticamente i dati ambientali raccolti, utilizzando una terminologia scientifica appropriata e adottando un metodo rigoroso;
• Acquisirà la capacità di riconoscere le interrelazioni tra le diverse componenti ambientali, sia abiotiche sia biotiche;
• Svilupperà competenze di lavoro di gruppo, migliorando la propria capacità di comunicazione, cooperazione e confronto tra pari;
• Rafforzerà le proprie abilità nella redazione di relazioni tecniche e scientifiche, attraverso la produzione di un elaborato finale che dimostri non solo l’apprendimento degli argomenti trattati, ma anche capacità di organizzazione, sintesi, critica e discussione dei dati raccolti.
Prerequisiti
1. aver superato con esito positivo i seguenti esami del primo anno: Chimica Generale e Inorganica e Laboratorio, Principi di Biologia Animale e Vegetale, Laboratorio di Biodiversità, Fondamenti di Scienze della Terra e Laboratorio;
2. aver frequentato i corsi di laboratorio del secondo anno (Chimica Analitica e Laboratorio, Ecologia I e Laboratorio di Metodi di Analisi di Sistemi Ecologici, Geografia Fisica e Geomorfologia) in quanto, durante le attività in campo, verranno applicate le conoscenze laboratoriali acquisite in questi insegnamenti.
Per accedere al Laboratorio in Campo, il requisito di cui al punto 1. dovrà essere raggiunto entro e non oltre la fine della sessione di esami invernale (febbraio 2026).
Contenuti
1. Lezioni preparatorie pre-campo
Le attività didattiche introduttive comprendono lezioni teoriche e pratiche mirate a fornire agli studenti un inquadramento generale delle tematiche affrontate durante il laboratorio, delle tecniche che verranno utilizzate sul campo, delle norme di sicurezza e delle modalità di redazione della relazione finale. Le lezioni, obbligatorie, si svolgeranno nelle settimane precedenti l’uscita didattica.
2. Attività sul campo
Il laboratorio si svolgerà nel territorio del Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino, che fungerà da aula a cielo aperto per l’approccio multidisciplinare previsto. Gli studenti soggiorneranno per circa una settimana in ambiente montano, nelle località di Falcade (BL), Predazzo (TN), Passo Valles (BL-TN) e Passo Rolle (TN).
Durante il laboratorio, verranno effettuate escursioni giornaliere in cui saranno applicate metodologie di indagine sul campo per il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
• Studio strutturale e stratigrafico delle sequenze sedimentarie affioranti e interpretazione geomorfologica del paesaggio;
• Monitoraggio della qualità dell’aria mediante campionamento di filtri per PM10, raccolta di dati meteorologici con stazione meteo e pluviometro;
• Campionamento e analisi delle comunità vegetali;
• Campionamento e studio della vegetazione acquatica (macrofite e microalghe) e della fauna macrobentonica fluviale, con valutazione dello stato ecologico dei corsi d’acqua;
• Misure in situ dei parametri chimico-fisici delle acque (pH, ossigeno disciolto, temperatura, conducibilità);
• Analisi chimiche delle acque (fosfati, nitriti, nitrati, solfati);
• Rilievo del territorio mediante l’impiego di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR).
3. Rielaborazione e presentazione dei dati
La fase finale prevede l’analisi e l’elaborazione dei dati raccolti durante le attività sul campo. Tali elaborazioni confluiranno nella stesura di una relazione tecnica finale, in cui gli studenti dovranno dimostrare la comprensione critica delle attività svolte, la padronanza delle metodologie applicate e la capacità di comunicare i risultati in forma scientifica.
Nota: alcune delle attività previste, così come le modalità operative, potranno subire variazioni in funzione delle condizioni meteorologiche, della logistica e della programmazione didattica dell’anno accademico di riferimento.
Testi di riferimento
Modalità di verifica dell'apprendimento
La verifica dell’apprendimento del Laboratorio in campo si basa su due prove:
i) la valutazione di una relazione scritta di gruppo;
ii) una prova scritta individuale.
i) Relazione scritta di gruppo
L’elaborato consiste in una relazione scientifica sulle attività svolte sul terreno e deve:
• presentare il contesto dell’area di studio;
• descrivere le attività svolte e i loro fondamenti scientifici;
• illustrare le procedure di campionamento, analisi ed elaborazione dei dati;
• sintetizzare e interpretare criticamente i risultati ottenuti;
• discutere i risultati dal punto di vista ambientale, con rigore scientifico, in una prospettiva sia monodisciplinare sia multidisciplinare;
• evidenziare le interconnessioni tra le diverse discipline affrontate durante il laboratorio.
La relazione sarà valutata dai docenti, che attribuiranno un voto (in trentesimi) a ciascuna sezione disciplinare del documento. Tutte le sezioni devono ottenere un punteggio minimo pari a 18/30: in tal caso, il voto finale della relazione sarà calcolato come media aritmetica dei voti delle singole sezioni.
Il voto ottenuto deve essere accettato o rifiutato congiuntamente da tutti i componenti del gruppo.
Ogni relazione di gruppo deve rappresentare un lavoro originale. La copiatura parziale o totale di materiali di anni precedenti, o il semplice “copia e incolla” da fonti online, comporteranno l’annullamento della prova.
Solo dopo aver superato questa fase si sarà ammessi alla prova scritta individuale.
ii) Prova scritta individuale
Consiste in un test a risposta multipla relativo a tutti i contenuti affrontati durante il laboratorio in campo. Per accedere alla prova, è necessario:
• consegnare la relazione di gruppo entro i tempi previsti;
• aver ottenuto un punteggio sufficiente (≥18/30) in tutte le sezioni che compongono l’elaborato.
Votazione finale
Il voto finale dell’esame è determinato dall’integrazione dei risultati delle due prove:
• la relazione di gruppo pesa per due terzi (2/3) del voto complessivo;
• la prova scritta individuale pesa per un terzo (1/3).
Esempio di calcolo del voto finale:
Relazione di gruppo: 24/30
Prova scritta individuale: 30/30
Voto finale: (24 × 2/3) + (30 × 1/3) = 16 + 10 = 26/30
Modalità di esame
Graduazione dei voti
28-30 e lode: Ottima padronanza degli argomenti trattati durante il campo; eccellente capacità di selezionare e gerarchizzare le informazioni; utilizzo appropriato e preciso della terminologia tecnica; partecipazione attiva e propositiva sia alle attività sul campo sia al lavoro di gruppo.
26-27: Buona conoscenza degli argomenti affrontati; buona capacità di organizzazione e presentazione delle informazioni; uso generalmente corretto della terminologia tecnica; partecipazione costante alle attività sul campo e al lavoro di gruppo.
24-25: Conoscenza sufficiente ma non sempre approfondita dei contenuti trattati; esposizione ordinata ma con alcuni errori terminologici; partecipazione regolare, seppur non sempre attiva, alle attività sul campo e al lavoro di gruppo.
22-23: Conoscenze parziali e spesso superficiali; esposizione poco chiara, con frequenti imprecisioni terminologiche; partecipazione minima ma sufficiente alle attività previste.
18-21: Conoscenze lacunose e frammentarie; esposizione confusa, con scarso utilizzo della terminologia tecnica; partecipazione marginale alle attività sul campo e al lavoro di gruppo.
Metodi didattici
• Attività pratiche sul campo, incluse escursioni, campionamenti e osservazioni;
• Lavoro in piccoli gruppi per favorire la collaborazione e l'apprendimento tra pari;
• Discussioni guidate e analisi critica dei dati raccolti;
• Incontri preparatori prima del lavoro sul campo e sessioni di debriefing post-campo.
Inoltre, saranno trattati concetti chiave relativi alla salute e alla sicurezza nelle attività all'aperto.
Altre informazioni
Accomodamenti e Servizi di Supporto per studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento:
Ca’ Foscari applica la Legge Italiana (Legge 17/1999; Legge 170/2010) per i servizi di supporto e di accomodamento disponibili agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento. In caso di disabilità motoria, visiva, dell’udito o altre disabilità (Legge 17/1999) o un disturbo specifico dell’apprendimento (Legge 170/2010) e si necessita di supporto (assistenza in aula, ausili tecnologici per lo svolgimento di esami o esami individualizzati, materiale in formato accessibile, recupero appunti, tutorato specialistico a supporto dello studio, interpreti o altro), si contatti l’ufficio Disabilità e DSA disabilita@unive.it.
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Questo insegnamento tratta argomenti connessi alla macroarea "Capitale naturale e qualità dell'ambiente" e concorre alla realizzazione dei relativi obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile