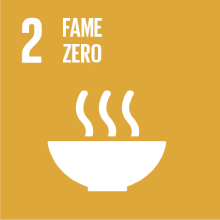MICROECONOMICS 1
- Anno accademico
- 2025/2026 Programmi anni precedenti
- Titolo corso in inglese
- MICROECONOMICS 1
- Codice insegnamento
- EM2Q01 (AF:561360 AR:327738)
- Lingua di insegnamento
- Inglese
- Modalità
- In presenza
- Crediti formativi universitari
- 7
- Livello laurea
- Laurea magistrale (DM270)
- Settore scientifico disciplinare
- SECS-P/01
- Periodo
- I Semestre
- Anno corso
- 1
- Sede
- VENEZIA
- Spazio Moodle
- Link allo spazio del corso
Inquadramento dell'insegnamento nel percorso del corso di studio
Il corso è suddiviso in due parti. La prima parte presenta le scelte individuali di consumatori e produttori razionali in un contesto statico e deterministico. La seconda parte estende l’analisi delle decisioni individuali a un contesto stocastico e introduce lo studio dell’equilibrio generale, analizzando le proprietà di benessere degli equilibri competitivi.
Nel complesso, il corso offre un’introduzione sia alla teoria del consumo e della produzione sia alla loro interazione in un equilibrio generale. A differenza della normativa di ateneo, che equipara 1 CFU a 3,75 ore di lezione frontale, questo corso da 7 CFU segue una struttura differente, con 1 CFU corrispondente a 6,43 ore di lezione frontale.
Risultati di apprendimento attesi
Il corso è frequentato sia dagli studenti del programma QEM sia dagli studenti del primo anno di dottorato che non hanno già seguito un corso con contenuti simili e/o con un analogo livello di formalizzazione nel loro percorso accademico precedente.
1. Conoscenze e competenze:
a) solida conoscenza delle basi teoriche e comportamentali della teoria del consumatore
b) solida conoscenza delle basi teoriche della teoria della produzione
c) capacità di integrare le decisioni di consumo e produzione nella formulazione di un equilibrio competitivo
d) solida conoscenza dei teoremi del benessere, dei loro limiti e delle loro implicazioni
2. Applicazione delle conoscenze e competenze acquisite:
a) capacità di analizzare, comprendere e interpretare fenomeni economici e finanziari stilizzati attraverso l’analisi microeconomica
b) capacità di utilizzare gli strumenti dell’analisi microeconomica per valutare affermazioni di natura positiva e normativa
c) capacità di costruire modelli formali di equilibrio competitivo in differenti strutture di mercato
3. Capacità di giudizio e di interpretazione:
a) capacità di valutare i tipici trade-off nelle scelte ottimali di consumo e produzione
b) capacità di interpretare gli esiti dell’equilibrio di mercato alla luce delle ipotesi comportamentali e tecnologiche
c) capacità di mettere in relazione l’efficienza dell’equilibrio di mercato con le ipotesi comportamentali e tecnologiche
Prerequisiti
Contenuti
Parte A
1) Teoria del comportamento del consumatore: relazioni di preferenza, regole di scelta, insieme di consumo, vincolo di bilancio competitivo, funzione di domanda, preferenze e utilità, problema di massimizzazione dell’utilità, problema di minimizzazione della spesa.
2) Teoria della produzione: insiemi di produzione, funzioni di produzione e di costo, massimizzazione del profitto e minimizzazione del costo, produzione efficiente.
Parte B
3) Scelte in condizioni di incertezza: teoria dell’utilità attesa, lotterie monetarie e avversione al rischio.
4) Introduzione all’equilibrio generale: il diagramma di Edgeworth e l’economia di Robinson Crusoe.
5) Ottimalità paretiana, equilibrio competitivo e le sue proprietà di benessere (primo e secondo teorema del benessere).
Testi di riferimento
Mas-Colell, Andreu, Michael Dennis Whinston e Jerry R. Green (1995), *Microeconomic Theory*. New York: Oxford University Press.
Il corso copre i materiali dei seguenti capitoli: Cap. 1-6, 10, 15-17, 19
Per la parte introduttiva si consiglia la lettura di:
Hausman, Daniel M. (2003), *"Philosophy of Economics"*, disponibile al link: [https://stanford.library.sydney.edu.au/entries/economics/](https://stanford.library.sydney.edu.au/entries/economics/ )
Sandmo, Agnar, *Economics Evolving: A History of Economic Thought*. Princeton University Press, 2011.
Stigler, George H. (1950), “The Development of Utility Theory. I”, *Journal of Political Economy*, vol. 58, pp. 307–327.
Stigler, George H. (1950), “The Development of Utility Theory. II”, *Journal of Political Economy*, vol. 58, pp. 373–396.
Varian, Hal R. (1998), *"Microeconomics"*, in J. Eatwell, M. Milgate e P. Newman (a cura di), *The New Palgrave Dictionary of Economics*. Palgrave Publishers Ltd., 1998.
Una pagina dedicata al corso è attiva sulla piattaforma di e-learning all’indirizzo: [moodle.unive.it](https://moodle.unive.it ). La pagina conterrà riferimenti a letture aggiuntive tratte da riviste scientifiche, esercizi, dettagli sul programma settimanale e le lezioni, oltre ad altri materiali utili.
Modalità di verifica dell'apprendimento
---
Esame scritto
Ogni anno accademico prevede quattro appelli d’esame. Il primo si svolge durante il primo semestre e si articola in: una prova scritta parziale intermedia sui contenuti della Parte A, somministrata al termine del primo periodo didattico; una prova scritta finale sull’intero contenuto del corso, somministrata al termine del secondo periodo didattico.
La valutazione finale è calcolata come media ponderata delle due prove (rispettivamente 30% e 50%) e della partecipazione attiva alle lezioni (20%). Gli appelli successivi (da gennaio a settembre) prevedono un unico esame scritto completo su tutti i contenuti del corso.
Tutte le prove scritte sono composte da esercizi simili a quelli svolti durante il corso e da domande teoriche, ciascuna con un punteggio assegnato. Gli esami sono a libro chiuso e senza appunti. È consentito l’uso di una calcolatrice tascabile.
Modalità di esame
Graduazione dei voti
A ciascuna domanda viene assegnato un punteggio, e la somma dei punti ottenuti determina il voto finale, espresso in trentesimi, con possibilità di lode per punteggi superiori a 30. Il voto minimo per superare l’esame è 18/30.
I voti compresi tra 18 e 22 saranno assegnati in caso di:
- conoscenza sufficiente dei principali contenuti del programma
- capacità limitata di risolvere gli esercizi
I voti compresi tra 23 e 26 saranno assegnati in caso di:
- conoscenza discreta dei principali contenuti del programma
- discreta capacità di risolvere gli esercizi
I voti compresi tra 27 e 30 saranno assegnati in caso di:
- buona o ottima conoscenza dei principali contenuti del programma
- buona o ottima capacità di risolvere gli esercizi, elaborarli e interpretarne i risultati, anche fornendo una visione critica
Il voto 30 e lode è assegnato agli studenti che dimostrano eccellenti capacità nella gestione dei contenuti del corso, abilità nella risoluzione degli esercizi e spiccate capacità critiche.
Metodi didattici
L’insegnamento è articolato in quindici lezioni per ciascuna delle due parti del corso. Inoltre, gli studenti hanno la possibilità di partecipare a cinque lezioni supplementari per ogni parte, durante le quali un tutor svolge esercizi selezionati, distribuiti anticipatamente.
Il corso è frequentato sia dagli studenti del programma QEM sia dagli studenti del primo anno di dottorato che non hanno seguito corso di uguale contenuto e/o rigore formale in passato. Le lezioni sono condivise da entrambi i gruppi. Tuttavia, agli studenti del dottorato può essere richiesto di approfondire in modo autonomo materiali più avanzati su alcuni argomenti specifici.
Altre informazioni
---
Accessibilità, Disabilità e Inclusione
Misure compensative e servizi di supporto per studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
Ca’ Foscari osserva quanto previsto dalla normativa italiana (Legge 17/1999; Legge 170/2010) in materia di servizi di supporto e misure compensative per studenti con disabilità. Questo include studenti con disabilità motorie, visive, uditive e altre forme di disabilità (Legge 17/1999), nonché studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (Legge 170/2010).
Se sei uno studente con disabilità o DSA e hai bisogno di misure compensative (ad esempio: modalità alternative di esame, lettori, tutor alla pari o interpreti), ti invitiamo a contattare gli Uffici Disabilità e Accessibilità nei Servizi agli Studenti: disabilita@unive.it.
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Questo insegnamento tratta argomenti connessi alla macroarea "Povertà e disuguaglianze" e concorre alla realizzazione dei relativi obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile