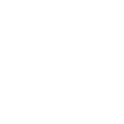PHILOSOPHICAL TOOLS TO UNDERSTAND THE PLANET'S HISTORY
- Anno accademico
- 2025/2026 Programmi anni precedenti
- Titolo corso in inglese
- PHILOSOPHICAL TOOLS TO UNDERSTAND THE PLANET'S HISTORY
- Codice insegnamento
- LMH035 (AF:575637 AR:322867)
- Lingua di insegnamento
- Inglese
- Modalità
- In presenza
- Crediti formativi universitari
- 6
- Livello laurea
- Laurea magistrale (DM270)
- Settore scientifico disciplinare
- M-STO/05
- Periodo
- I Semestre
- Anno corso
- 1
- Sede
- VENEZIA
- Spazio Moodle
- Link allo spazio del corso
Inquadramento dell'insegnamento nel percorso del corso di studio
Occuparsi di "Humanities" non è semplicemente studiare al di fuori del laboratorio come luogo iconico della ricerca delle scienze dure.
Implica un metodo filosofico e una prospettiva storica, che quando la misurazione numerica di solito cede, ci permette di fare affidamento sulla nostra capacità di immaginare narrazioni – anzi, sull' "umanità".
Terenzio, un antico drammaturgo romano, già 2000 anni fa scriveva "Sono un essere umano, nulla di ciò che è umano mi è estraneo", quindi le discipline umanistiche dovrebbero significare la somma totale delle attività degli esseri umani, delle società che gli esseri umani hanno costruito. Tuttavia, cosa succede quando aggiungiamo l'aggettivo "ambientale" alle discipline umanistiche?
Significa prendere in considerazione un sistema molto complesso di biodiversità e mutevolezza geologica che ha una sua storia, come ci insegna la storia della scienza.
Scopo del corso è imparare a pensare criticamente come è stato costruito il passato geologico del nostro Pianeta e la storia sociale delle relazioni multiple che gli esseri umani hanno intessuto con gli altri organismi viventi nel tempo e nello spazio geografico e di applicare l'approccio filosofico ai temi ambientali come strumento per analizzare la complessità di questi temi oggi, per poterci proiettare nel futuro del Pianeta senza abbandonarci ai soli modelli matematici.
Risultati di apprendimento attesi
Possedere, ed applicare, una prospettiva storica alla problematiche attuali.
Rielaborare criticamente le informazioni sull'ambiente e sulle politiche della scienza ricevute dai media e dagli scienziati.
Discutere e argomentare la propria analisi di queste informazioni, anche attracerso la tecnica del dibattito filosofico ("disputatio").
Prerequisiti
Avere una mente aperta, aver voglia di conoscere diversi approcci alle questioni ambientali, anche quelli molto lontani dalle proprie certezze.
Contenuti
Se tutti siamo d'accordo che lo studio della filosofia rientri nelle scienze umane, più difficile è stabilire se la geografia sia una scienza naturale o sociale. Perchè non è immediatamente chiaro? Ne discutermo insieme per decidere poi dove collocare la geologia. Perché è importante capire la distinzione e se è possibile farla? Perché concetti come Antropocene non si traslano dal discorso umanistico a quello geologico senza conseguenze, come abbiamo appreso dalle recenti decisioni dell'International Commission on Stratigraphy (ICS).
La prima parte del corso illustrerà gli strumenti concettuali e metodologici che la Filosofia e la Storia della Scienza offrono per orientarsi in quell'insieme indistinto di teorie e pratiche legate al discorso ambientale.
Nella seconda parte, le lezioni saranno dedicate specificamente ai disastri naturali del passato come oggetto di analisi da un approccio di Environmental Humanities. In questo caso, vulcani e terremoti sono “strumenti per pensare” la transdisciplinarietà di alcune dinamiche socio-politiche, il rapporto tra lo sviluppo delle discipline scientifiche e i luoghi di osservazione della natura, l'intenzionalità umana e la materialità dell'ambiente, la multidimensionalità delle catastrofi dall'età moderna. Affronteremo anche la percezione, la gestione e la prevenzione del rischio nella storia. Infine, discuteremo se la crisi ambientale è una catastrofe e, se lo è, in che misura.
Gli studenti parteciperanno anche ad alcuni workshop tenuti da professionisti, ad esempio del mondo del giornalismo, dell'architettura, delle scienze climatiche o delle biotecnologie, ecc. su temi che vanno dall'origine del rapporto tra turismo e cambiamento climatico alla rigenerazione delle periferie urbane. Si tratta di workshop con approcci e temi diversi, per cui gli studenti, utilizzando quanto appreso nella prima parte del corso, dovranno dimostrare di essere in grado di rielaborare criticamente le informazioni ricevute, discutere e argomentare la propria analisi dei contenuti.
Testi di riferimento
Comunque, studieremo alcune parti di:
- Dodds J.W., The Place of the Humanities in a World of War, Vital Speeches of the Day, 1943. Vol 9, Iss 10, pp. 311-314
- Zanoni E., Luciano E., Antonio Stoppani’s ‘Anthropozoic’ in the context of the Anthropocene, BJHS, DOI 10.1017/s0007087422000590
- Arendt, Between Past and Future (1961) [any edition];
- Armiero M., Wasteocene: Stories from the Global Dump, Cambridge University Press, 2021;
- Grafton H. & Torrence R. Natural Disasters and Cultural Change. London New York: Routledge, 2002
- Guerra C. & Piazza M., Disruption of Habits during the Pandemic, Milan, Mimesis International, 2022
- Horn E., The Future as Catastrophe: Imagining Disaster in the Modern Age, Translated by V. Pakis. Columbia University, 2018
Modalità di verifica dell'apprendimento
- la loro partecipazione attiva alle lezioni
- un esame orale finale
- presentazioni alla classe/saggio su un workshop (facoltativo).
Lo scopo è offrire a ciascun studente l'opportunità di esprimere al meglio le proprie capacità.
Modalità di esame
Graduazione dei voti
20-23: conoscenza di base dei contenuti del corso
24-27: buona conoscenza dei contenuti del corso con parziale applicazione autonoma degli strumenti concettuali e dei contenuti disciplinari
28-30: ottima conoscenza dei contenuti del corso e applicazione autonoma degli strumenti concettuali e dei contenuti disciplinari
30 Lode: ottima conoscenza dei contenuti del corso, ottima applicazione degli strumenti concettuali e dei contenuti disciplinari
Metodi didattici
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Questo insegnamento tratta argomenti connessi alla macroarea "Cambiamento climatico e energia" e concorre alla realizzazione dei relativi obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile