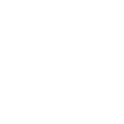ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA II
- Anno accademico
- 2025/2026 Programmi anni precedenti
- Titolo corso in inglese
- PHOENICIAN-PUNIC ARCHAEOLOGY II
- Codice insegnamento
- FT0523 (AF:577672 AR:325851)
- Lingua di insegnamento
- Italiano
- Modalità
- Blended (in presenza e online)
- Crediti formativi universitari
- 6 su 12 di ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA
- Livello laurea
- Laurea
- Settore scientifico disciplinare
- L-OR/06
- Periodo
- 2° Periodo
- Spazio Moodle
- Link allo spazio del corso
Inquadramento dell'insegnamento nel percorso del corso di studio
Il corso contribuisce a fornire una solida preparazione storica, culturale e metodologica nell’ambito dell’archeologia mediterranea. In particolare, mira a sviluppare conoscenze avanzate sulla civiltà fenicia e punica, con attenzione specifica alla sua espansione nel Mediterraneo occidentale e alle interazioni con le civiltà coeve del mondo antico. Promuove inoltre capacità di analisi critica e di interpretazione dei contesti archeologici, fornendo competenze utili per l’indagine sul campo e lo studio dei materiali, in linea con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.
Gli studenti provenienti da altri corsi di studio o con esigenze specifiche che desiderino approfondire i temi trattati sono i benvenuti e invitati a contattare il docente per concordare modalità di frequenza e studio più adatte alle proprie necessità.
L’insegnamento è collegato al progetto di ricerca e scavo nel tofet di Bithia (Chia, Domus de Maria – Sud Sardegna), attivo dal 2021 sotto la direzione dei docenti Alessandra Gilibert e Stefano Floris e aperto alla partecipazione degli studenti. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione si rimanda alla sezione “Altre informazioni” oppure si invita a contattare direttamente i docenti.
Risultati di apprendimento attesi
[Conoscenza e comprensione]
• comprendere e utilizzare correttamente la terminologia archeologica di base;
• conoscere le principali coordinate geografiche del Mediterraneo antico;
• conoscere i lineamenti cronologici e storici del Mediterraneo nel periodo compreso tra l’inizio della colonizzazione fenicia e la distruzione di Cartagine (IX–II sec. a.C.);
• conoscere gli snodi fondamentali della storia degli studi sull’archeologia fenicio-punica;
• conoscere le principali fonti e i modelli teorici di riferimento per l’analisi dei contesti sacri e funerari fenici e punici;
• riconoscere, descrivere e inquadrare gli elementi essenziali della cultura materiale, dell’architettura e dell’urbanistica fenicio-punica;
[Capacità di applicare conoscenza e comprensione]
• utilizzare correttamente la terminologia archeologica di base e, in particolare, quella specifica degli studi fenici;
• localizzare i principali siti archeologici del Mediterraneo centrale e occidentale;
• identificare complessi architettonici e manufatti significativi trattati durante le lezioni;
• contestualizzare cronologicamente le principali espressioni della cultura materiale e artistica fenicia e punica;
• individuare correttamente i metodi di analisi adeguati alle finalità e alle fonti disponibili per una determinata ricerca;
[Autonomia di giudizio]
• formulare e argomentare in modo autonomo ipotesi interpretative su temi, contesti e materiali relativi all’archeologia fenicio-punica;
• esprimere giudizi critici su testi scientifici;
[Abilità comunicative]
• descrivere, analizzare e discutere con terminologia appropriata e in modo rispettoso i contenuti studiati durante il corso;
• cooperare per risolvere problemi legati allo studio di un contesto archeologico, utilizzando e analizzando criticamente le fonti disponibili;
• comunicare con padronanza terminologica aspetti del patrimonio archeologico mediterraneo;
[Capacità di apprendimento]
• individuare rapidamente la struttura e i punti essenziali di un articolo scientifico;
• consultare criticamente i testi scientifici ed estendere l’approfondimento alla bibliografia di riferimento in lingua italiana e straniera.
Prerequisiti
• aver conseguitogli obiettivi formativi di “Archeologia fenicio-punica I” anche senza aver necessariamente superato l’esame di tale insegnamento;
• avere una buona capacità di comprensione della lingua inglese, francese, e/o spagnola scritta, poiché la bibliografia consigliata in classe potrà includere articoli o saggi in tali lingue.
Contenuti
In particolare, l’insegnamento approfondisce il ruolo degli spazi sacri e funerari nella costruzione delle identità e nello sviluppo degli insediamenti nel contesto della colonizzazione fenicia del Mediterraneo occidentale. Il tema sarà affrontato attraverso l’analisi integrata di diverse tipologie di fonti (archeologiche, visive e testuali) e di casi studio selezionati.
Particolare attenzione sarà riservata all’archeologia dei santuari infantili a incinerazione (tophet) nelle principali colonie fenicie del Mediterraneo centrale (Nord Africa, Malta, Sicilia e Sardegna). Saranno esaminate in modo critico le fonti disponibili, gli approcci metodologici interdisciplinari comunemente impiegati nello studio di questi contesti e i modelli teorici utilizzati per la loro interpretazione.
Testi di riferimento
Testi obbligatori (Per un’introduzione sul tophet):
• Xella P., Il tophet. Un’interpretazione generale, in S. Angiolillo – M. Giuman – C. Pilo (a cura di), Meixis. Dinamiche di stratificazione culturale nella periferia greca e romana. Atti del Convegno Internazionale di Studi “Il sacro e il profano” (Cagliari, 5–7 maggio 2011), Roma: Giorgio Bretschneider, 2012, pp. 1–17.
• Ciasca A., Archeologia del tofet, in C. González Wagner – L.A. Ruiz Cabrero (a cura di), El Molk como concepto del sacrificio púnico y hebreo y el final del dios Moloch, Madrid: Centro de estudios fenicios y punicos, 2002, pp. 121–140.
• Floris S., Il tofet di Tharros, Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2022 [pp. 24-28, 259-272].
Facoltativi (Manuali e testi di consultazione o approfondimento):
• Bondì S.F., Botto M., Garbati G., Oggiano I., Fenici e Cartaginesi. Una civiltà mediterranea, Roma: Libreria dello Stato, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 2009.
• Del Vais C., Guirguis M., Stiglitz A. (a cura di), Il tempo dei Fenici. Incontri in Sardegna dall’VIII al III sec. a.C., Nuoro: Ilisso, 2019.
La bibliografia di riferimento per il corso e per l’esame sarà presentata in classe, e alcuni testi saranno oggetto di discussione collettiva durante le lezioni.
Ulteriori letture di approfondimento potranno essere suggerite dal docente in base agli interessi emersi e alle esigenze specifiche degli studenti.
Modalità di verifica dell'apprendimento
La presentazione sarà valutata sulla base di:
• padronanza dei contenuti trattati nel corso;
• uso appropriato della terminologia specialistica;
• capacità di analisi critica e di collegamento tra contesti, fonti e approcci teorici;
• autonomia nell’organizzazione e nell’elaborazione dei materiali.
Modalità di esame
Graduazione dei voti
Sufficiente (18-22/30)
• Conoscenza parziale e poco approfondita dell’argomento trattato.
• Esposizione essenziale, talvolta mnemonica o poco articolata.
• Linguaggio semplice e utilizzo incerto della terminologia specialistica.
Buono (23-26/30)
• Conoscenza adeguata e corretta dell’argomento trattato, con esposizione generalmente chiara.
• Alcune incertezze nell’approfondimento o nella capacità di contestualizzazione.
• Linguaggio tecnico corretto, ma non sempre fluido.
Ottimo (27-30/30)
• Conoscenza solida e articolata dell’argomento.
• Esposizione chiara e ben strutturata, con uso sicuro del lessico disciplinare.
• Buona capacità di collegamento tra materiali, contesti e temi trasversali.
Eccellente (30/30 e lode)
• Conoscenza completa e aggiornata dell’argomento trattato.
• Capacità critica ed espositiva eccellente, con linguaggio tecnico appropriato.
• Struttura della presentazione ben organizzata, ricca di esempi e collegamenti autonomi con altri temi rilevanti.
• Notevole autonomia e originalità nell’elaborazione dei contenuti.
Metodi didattici
Nell’ambito di queste attività, potrà essere richiesto ai partecipanti di:
• familiarizzarsi con le fonti primarie e con i principali dibattiti scientifici attraverso la lettura di articoli o capitoli assegnati prima della lezione, e la loro discussione in aula secondo linee guida fornite in anticipo;
• descrivere, analizzare e discutere in gruppo fonti visive e materiali presentati in classe, sviluppando capacità analitiche, interpretative e argomentative;
• partecipare a seminari tematici dedicati a casi di studio specifici – es. il progetto di scavo del tofet di Bithia;
• collaborare alla progettazione e realizzazione di un progetto finale a scelta (ad es. infografiche, bozza di pannello espositivo, guida di sito o museo, itinerario di visita, progetto di mostra), ispirato ai contenuti del corso.
L’insegnamento riconosce e valorizza la diversità delle esperienze, degli stili cognitivi e delle condizioni personali degli studenti, per questo motivo promuove un ambiente di apprendimento rispettoso, accessibile e collaborativo.
La partecipazione attiva alle attività proposte è quindi raccomandata e valorizzata, ma non è obbligatoria né condizione necessaria per il pieno superamento dell’esame.
Gli studenti che, per qualsiasi motivo, non potessero o non desiderassero intervenire attivamente nel dibattito sono comunque invitati a prendere parte alle lezioni come uditori attenti e partecipi. Forme alternative di partecipazione e preparazione possono essere concordate con il docente.
Altre informazioni
Durante il corso saranno fornite informazioni approfondite sul progetto di scavo nel tofet di Bithia (Chia, Domus de Maria – Sud Sardegna) e gli studenti che hanno inserito l'insegnamento nel proprio piano di studi potranno candidarsi per partecipare alla campagna. La partecipazione all’insegnamento costituisce un requisito preferenziale, ma non vincolante, ai fini della selezione. Si precisa che la frequenza al corso non garantisce in alcun modo l’ammissione automatica allo scavo, che avverrà sulla base di criteri stabiliti dalla direzione scientifica del progetto.
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Questo insegnamento tratta argomenti connessi alla macroarea "Capitale umano, salute, educazione" e concorre alla realizzazione dei relativi obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile