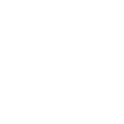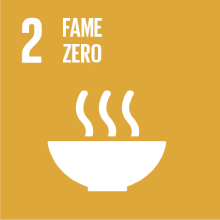CRITICAL THINKING
- Anno accademico
- 2025/2026 Programmi anni precedenti
- Titolo corso in inglese
- CRITICAL THINKING
- Codice insegnamento
- LM6450 (AF:594532 AR:322029)
- Lingua di insegnamento
- Inglese
- Modalità
- In presenza
- Crediti formativi universitari
- 6
- Livello laurea
- Laurea magistrale (DM270)
- Settore scientifico disciplinare
- L-LIN/11
- Periodo
- I Semestre
- Anno corso
- 2
- Sede
- VENEZIA
- Spazio Moodle
- Link allo spazio del corso
Inquadramento dell'insegnamento nel percorso del corso di studio
Il tema prescelto per realizzare questi obiettivi è: la figura del Public Intellectual. Esiste? Se sì, come è possibile descriverla? Come è emersa questa figura in passato? Perché? Come possiamo riconoscere questa figura nel presente? Nel nostro corso, affronteremo queste e altre domande correlate. Allo stesso tempo, utilizzeremo queste domande per illuminare un periodo entusiasmante della storia culturale, letteraria e politica americana, il periodo che va dalla metà del XX secolo in poi. È il momento in cui la città di New York emerge come nuovo centro delle avanguardie artistiche e come polo culturale e creativo, con le grandi figure di rifugiati ebrei europei come Hannah Arendt e Susan Taubes, e voci innovative come quella di Susan Sontag (1933-2004), tra le altre.
Prima di arrivare a questo entusiasmante periodo storico e, da lì, al presente, inquadreremo il nostro corso individuando alcuni modelli di Public Intellectual il cui influsso è transtorico e transculturale. Nella prima parte del corso esamineremo Antigone, San Paolo (Paolo di Tarso), e Stephen Dedalus di James Joyce come modelli di quello che Julia Kristeva nella nostra epoca ha definito l'intellettuale "dissidente". Nel caso di Antigone e Paolo vedremo come siano stati attualizzati da pensatori contemporanei (Judith Butler e Alain Badiou) e trarremo dall'incontro con queste due figure universali alcuni degli strumenti teorici per la nostra indagine. Ci trasferiremo poi a New York della metà del XX secolo, con le figure di grandi pensatrici come Arendt, Sontag e Taubes, per arrivare ai giorni nostri e affrontare il pensiero critico sulla razza (Afropessimism) e, infine, il pensatori del soggetto post--traumatico particolarmente influenti nel mondo anglofono (Catherine Malabou e Slavoj Žižek).
Risultati di apprendimento attesi
(conoscenze e capacità di comprensione)
• leggere, comprendere e interpretare testi e affinare un atteggiamento critico nel rispetto dell’oggetto di studio e dell’altro
• capire che la lettura, la riflessione sui testi, e la scrittura come pratiche collegate, simultanee e inseparabili l’una dall’altra
• riconoscere i tratti distintivi e gli scopi della scrittura accademica
• creare collegamenti tra idee e/o autori diversi, comprendendone il contributo specifico al dibattito accademico e alla ricerca
(applicazione delle conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi)
• saper individuare una questione importante in maniera autonoma
• saper condurre ricerche in biblioteca, navigare i principali database, individuare e valutare fonti pertinenti e valide
• sviluppare e applicare la conoscenza delle convenzioni della scrittura accademica relativamente alla struttura di un saggio, alla sua composizione in paragrafi, al registro linguistico
(capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità)
• mappare le ricerche più interessanti e pertinenti su un argomento di interesse o problema importante
• produrre testi accademici di crescente lunghezza, e contribuire a una conversazione su un argomento o problema importante avanzando una posizione ben documentata
• sviluppare una consapevolezza del contesto e del tipo di destinatario
(comunicare in modo chiaro)
• riassumere e parafrasare testi complessi, coglierne l’argomentazione principale, condividere un proprio testo con un pubblico di pari, scambiare impressioni e suggerimenti
costruttivi
• prendere parte a un dibattito presentando un punto di vista e offrendo un contributo
• collaborare on i pari durante la discussione dei testi, nell’organizzazione di un dibattito, e articolare le proprie impressioni a beneficio degli altri
(capacità di apprendimento)
• sviluppare capacità argometative
• riassumere, parafrasare e citare fonti usando l’ MLA documentation style
• riscrivere un testo, apportando revisioni, correggendo errori di sintassi, grammatica, punteggiatura e spelling
• prendere note
• compilare una bibliografia di fonti valide
• Formulare una proposta di ricerca finalizzata alla produzione di un saggio.
Prerequisiti
Contenuti
1. Introduction to the course: The Public Intellectual, an Open Debate
2. Antigone
3. Feminist readings of Antigone for our time
4. Paul, Our Contemporary
5. Roundtable 1: Cross-temporal models of the public intellectual
6. Joyce's Stephen
7. Susan Taubes
8. Roundtable 2: Susan Taubes
9. Hannah Arendt and the space of appearance
10. Roundtable 3: Women Public Intellectuals (Sontag/Taubes/Arendt)
11. Later Sontag: Regarding the Pain of Others
13. Psychoanalysis, race, and the public intellectual: the case of Afro-pessimism
14. Destruction and the “New Wounded”: Catherine Malabou and Slavoj Žižek
15. Roundtable 4: Does the Public Intellectual Exist?
Testi di riferimento
Julia Kristeva, “A New Type of Intellectual: The Dissident.” Trans. Seán Hand. The Kristeva Reader. Ed. Toril Moi. New York: Columbia University Press, 1986. 292–300. Moodle
Sophocles, Antigone. Trans. Robert Fagles. Penguin Classics, 2015. Print: Libreria Cafoscarina.
Paul, “The Second Letter to the Thessalonians.” The Bible, English Standard Version-ESV and King James Version – KJV). Moodle
Badiou, Alain, “Who is Paul?” from Saint Paul. The Foundation of Universalism. Trans. Ray Brassier. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003. 16-30. Moodle
Pier Paolo Pasolini, St. Paul: A Screenplay. Trans. Elizabeth A. Castelli. London: Verso, 2014. Moodle.
Adriana Cavarero, “On the Body of Antigone.” In Feminist Readings of Antigone. Ed. Fanny Soderback. New York: State University of New York Press, 2010. 45-63. To read: pp. 45-55, and Conclusion: 59-60. Moodle.
Judith Butler, “Promiscuous Obedience.” In Feminist Readings of Antigone. Ed. Fanny Soderback. New York: State University of New York Press, 2010. To read: pp. 45-55, and Conclusion: 59-60. Moodle.
Arendt, Hannah, “The Public Realm: The Common,” and “Power and the Space of Appearance,” and “Homo Faber and the Space of Appearance.” The Human Condition. Intro. Margaret Canovan. Chicago: The University of Chicago Press, 1998. 50-57; 199-212. Moodle
Susan Taubes, Divorcing. Introd. David Rieff. (New York: NYRB Classics, 2020). Print: Libreria Cafoscarina
S. Sontag, “Notes on Camp.” Against Interpretation. New York: Picador, 2001. 275-292. Moodle
Susan Sontag, “Against Interpretation.” Against Interpretation. New York: Picador, 2001. First ed. 1966. 3-14. Moodle
S. Sontag, “Debriefing.” I, etcetera. New York: Picador, 2002. 33-52. Moodle
Susan Sontag, “Under the Sign of Saturn.” Under the Sign of Saturn. New York: Writers and Readers Publishing, 1983. First published 1980. 109-134. Moodle
S. Sontag, Regarding the Pain of Others. Penguin, 2003. Print: Libreria Cafoscarina
Edward Said, “Speaking Truth to Power.” Representations of the Intellectual. New York: Vintage, 1996. 85-102. Moodle
Marriot, David S. Lacan Noir: Lacan and Afro-pessimism. Palgrave Macmillan, 2021. 120-134. Moodle
Catherine Malabou, “Souffrance cérébrale, souffrance psychique et plasticité. Études, 414.4 (2011): 487-498. Moodle
Slavoj Žižek, “Descartes and the Post-Traumatic Subject: On Catherine Malabou's Les nouveaux blessés and Other Autistic Monsters.” Qui Parle, 17.2 (Spring-Summer 2009): 23-147. Moodle.
Letture consigliate:
Barbara Ching, “‘Not Even a New Yorker’”: Susan Sontag in America.” The Scandal of
Susan Sontag. Eds. Barbara Ching and Jennifer A. Wagner-Lawlor. New York: Columbia University Press, 2009. 52-77. Moodle
Michel Foucault, “What is Critique?” The Politics of Truth. Trans. Lysa Hochroth and Catherine Porter. Ed. Sylvère Lotringer. Los Angeles: Semiotext(e), 2007. 41-81. Moodle
bell hooks, “Intellectual Life.” Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom. Taylor & Francis Group, 2009. Moodle
Mena Mitrano, “The Public Intellectual.” In the Archive of Longing: Susan Sontag’s Critical Modernism. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016. 50-67. (Moodle)
Mena Mitrano, “What is Critique? Three Types of Indocility.” Literary Critique, Modernism and the Transformation of Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2022. 46-67.
Susan Sontag, “Against Interpretation.” Against Interpretation. New York: Picador, 2001. First ed. 1966. 3-14. Moodle
S. Sontag, “Trip to Hanoi.” Styles of Radical Will. New York: Picador, 2002. 205-274. Moodle
S. Sontag, “Fascinating Fascism.” Under the Sign of Saturn. New York: Writers and Readers Publishing, 1983. First published 1980. 73-105. Moodle
Susan Sontag, “Waiting for Godot in Sarajevo.” Where the Stress Falls. New York: Vintage, 2003. 299
Modalità di verifica dell'apprendimento
Il voto finale sarà il risultato dei seguenti elementi:
• saggio finale (frutto di un lavoro di ricerca)
• esame orale
L'esame orale durerà 30 minuti e si articolerà nella forma di una conversazione. Lo scopo della conversazione è di costruire sulle questioni che emergono dal lavoro di ricerca del singolo studente o studentessa, L’esame mirerà a verificare le seguenti capacità: 1) capacità di leggere, comprendere e commentare un testo con particolare attenzione a suo linguaggio; 2) capacità di analisi, collegando testi e idee e/o autori; 3) capacità di presentare e discutere i risultati della propria ricerca, entrando in conversazione con la letteratura critica esistente sulla questione o sull’argomento oggetto della ricerca individuale.
Il saggio finale sarà il frutto di un lavoro di ricerca su una questione o un argomento emersi dalla riflessione sui materiali del corso e concordato con la docente. Sarà lungo dalle 5 alle 7 pagine e dovrà avvalersi di almeno 4 fonti critiche. L’autore o autrice dovrà dimostrare di sapere inserirsi nella scholarship più recente esistente sull’argomento della ricerca e di sapere articolare il contributo del paper al dibattito.
E’ previsto un bonus per gli studenti e le studentesse che parteciperanno alla tavole rotonde.
Modalità di esame
Graduazione dei voti
La prima fascia: 18-22 (livello di base corrispondente a C nel sistema statunitense): sufficiente conoscenza dei contenuti; limitata capacità di discussione autonoma, limitata conoscenza degli strumenti teorici, limitata conoscenza del contesto storico-culturale e dei dibattiti.
La seconda fascia: 23-26 (livello intermedio corrispondente a B nel sistema statunitense): discreta conoscenza dei contenuti; discreta capacità di discussione autonoma, discreta conoscenza degli strumenti teorici, discreta conoscenza del contesto storico-culturale e dei dibattiti.
La terza fascia: 27-30 (livello buono o ottimo corrispondente a A nel sistema statunitense): buona o ottima conoscenza dei contenuti; buona o ottima capacità di discussione autonoma, buona o ottima conoscenza degli strumenti teorici, buona o ottima conoscenza del contesto storico-culturale e dei dibattiti.
Vi è inoltre la Lode: attribuita per evidenziare un livello eccellente della conoscenza dei contenuti, della capacità di discussione autonoma, della conoscenza degli strumenti teorici, e del contesto storico-culturale e dei dibattiti.
Metodi didattici
Student-led roundtables: ogni tavola rotonda è una opportunità per sviluppare competenze comunicative. Ogni tavola rotonda sarà animate e gestita dagli studenti e dalle studentesse che coordineranno i lavori di modo che ciascuno individualmente abbia uno spazio per presentare le proprie idee, basandosi soprattuto sulla lettura di un passo significativo da uno dei testi assegnati. Per facilitare il lavoro di tutti, ogni tavola rotonda avrà un titolo che presena un problema controverso e che quindi può essere discusso da varie cngolazioni. Lo scopo principale della tavola rotonda è creare uno spazio di dibattito tra pari ed espolrare i testi oggetto di studio dal punto di vista degli studenti e delle studentesse, sottolineanto problemi e questioni di particolare interesse per la comunità-classe. La tavola rotonda è interamente gestita dagli studenti e dalle studentesse con la supervisione della docente. Gli studenti che animano la tavola rotonda si assicureranno che ci sia spazio per il dibattito dopo le presentazioni. Subito dopo la tavola rotonda ogni partecipante dovrà far avere alla docente un paragrafo che riassuma il contributo individuale alla tavola rotonda.
Altre informazioni
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Questo insegnamento tratta argomenti connessi alla macroarea "Povertà e disuguaglianze" e concorre alla realizzazione dei relativi obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile