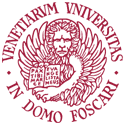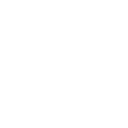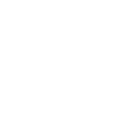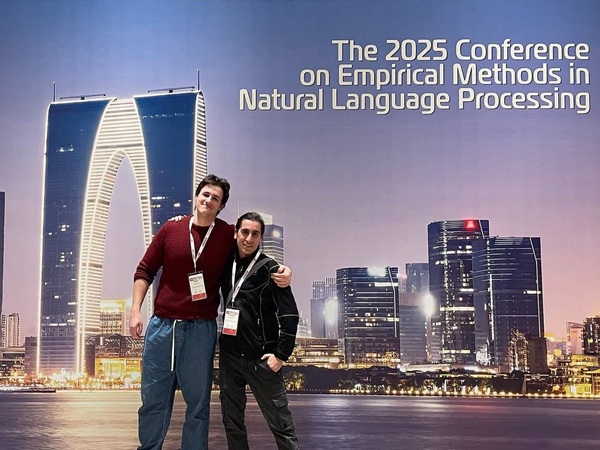Intervista a Sara Mohammed Mamon Ahmed, dottoranda all’Università di Khartoum e studentessa incoming Erasmus+ all’Università Ca’ Foscari Venezia

Sono una dottoranda del programma “Archaeology and Sciences” presso la Graduate College dell’Università di Khartoum, in Sudan. La mia ricerca si concentra su studi geoarcheologici nel Sudan settentrionale, in particolare nella Depressione di El Ga’ab, a ovest della città di Dongola, attraverso l’analisi di strumenti litici associati al periodo Paleolitico. Questa ricerca fa parte di un più ampio progetto scientifico intitolato: “Indagine archeologica, ambientale ed etnografica della Depressione di El Ga’ab, a ovest di Dongola”, supervisionato dal Professor Yahia Fadul Tahir, che è anche il direttore del progetto. L’obiettivo della ricerca è approfondire la conoscenza dei primi insediamenti umani nella regione e studiare la relazione tra l’uomo e il suo ambiente in epoca preistorica.
Quali sono le difficoltà maggiori per gli studenti e le studentesse universitarie sudanesi in tempo di guerra?
Una delle sfide più gravi è stata la chiusura delle università e la loro occupazione da parte di gruppi armati. Molti campus universitari hanno cessato di essere luoghi di apprendimento e conoscenza e sono divenuti campi di battaglia e zone di conflitto. L’interruzione dei servizi internet, insieme allo sfollamento di studenti e docenti verso aree più sicure dentro e fuori del Sudan, ha provocato ulteriori impedimenti al percorso accademico di molti. Altri sono rimasti intrappolati in zone di guerra, senza possibilità di fuga.
L’impatto si è esteso a tutte le istituzioni di formazione e ricerca, in particolare nella capitale Khartoum, dove la guerra è scoppiata. Khartoum è il centro accademico del Sudan e ospita la maggior parte delle università e dei principali centri di ricerca del Paese, per cui il conflitto ha avuto un effetto devastante sull’intero sistema educativo nazionale.
Nel mio caso particolare, io non sono riuscita a lasciare la capitale. Vivo da due anni, cioè dall’inizio della guerra, a Omdurman e più precisamente a Karari, una delle aree più colpite dalle varie ondate di disordini e scontri armati. In queste condizioni era difficilissimo svolgere qualsiasi attività accademica, sia di ricerca che di insegnamento, e si è acuito il mio senso di isolamento e di scollamento dalla comunità accademica.
Lei è qui a Venezia per un progetto di scambio Erasmus+ tra Venezia e Khartoum. Come è nata questa collaborazione e quali vantaggi comporta?
La collaborazione tra l’Università di Khartoum e l’Università Ca’ Foscari Venezia nasce da un accordo di cooperazione abbozzato prima dello scoppio della guerra in Sudan. Pur con tante difficoltà, lo sviluppo dell’accordo è proseguito e la firma ufficiale si è avuta a guerra già iniziata. Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno straordinario e convinto della Missione Archeologica Italiana attiva nel sito di Jebel Barkal, guidata dal Prof. Emanuele Ciampini e dalla direttrice sul campo, la dottoressa Francesca Iannarilli, in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Khartoum, rappresentato dal dott. Mohamed El Badri (capo dipartimento) e dalla dott.ssa Nuha Abdel Hafiz (responsabile delle relazioni internazionali).
Questa partnership offre a laureati e docenti di entrambe le istituzioni un’importante opportunità di scambio accademico, contribuendo alla formazione professionale, allo scambio di competenze e al dialogo con la comunità accademica internazionale.
Per me, questa occasione è arrivata in un momento particolarmente difficile. Mi ha offerto un ambiente sicuro e stimolante per proseguire la mia ricerca, restituendomi quel clima formativo che mi era mancato negli ultimi due anni.
Durante il periodo trascorso a Ca’ Foscari ho partecipato a diversi programmi di formazione, tra cui un corso di italiano che mi ha permesso di apprendere una nuova lingua e di avvicinarmi alla cultura italiana. Sono anche entrata in contatto con la vivace realtà veneziana. Attraverso il corso “Archeologia della città di Venezia”, ho approfondito la conoscenza della civiltà e delle relazioni internazionali della Repubblica di Venezia, arricchendo notevolmente il mio bagaglio di conoscenze archeologiche.
Una delle esperienze più significative è stata la formazione pratica da me svolta presso il laboratorio LAMA, che è stata un elemento essenziale per la mia ricerca di dottorato anche perché ha riacceso in me la speranza di poter continuare l’analisi di laboratorio sui reperti archeologici – una componente fondamentale del mio lavoro, resa impossibile dalla distruzione dei laboratori a Khartoum.
Ho inoltre partecipato al progetto della Missione Italiana “Jebel Barkal Archives”, che raccoglie mappe e fotografie della missione dal 1973. Sono anche intervenuta a un convegno organizzato nel Dipartimento di Studi Umanistici in collaborazione con la Missione Italiana, intitolato "SUDAN: Past and Present of a Country, a Memory, an Archaeological Heritage". Questo evento mi ha offerto una bellissima occasione di confronto con archeologi italiani e provenienti da tutto il mondo.
Sono inoltre stata a Roma dove ho visitato i principali siti archeologici, come il Colosseo e il Pantheon, e la prossima settimana parteciperò a un incontro a Torino sulla tutela del patrimonio culturale nelle zone di guerra. In questo periodo ho potuto migliorare molto il mio inglese, sia quotidiano che accademico, e avviare uno scambio culturale profondo con studenti provenienti da tutta Europa e non solo, dai quali ho appreso tradizioni e culture.
Questa esperienza è stata una vera svolta nel mio percorso accademico e personale e mi ha offerto strumenti, conoscenze e sostegno importantissimi.
Come le università sudanesi stanno affrontando la difficile situazione causata dalla guerra? Qual è il danno maggiore per l’attività accademica, e come stanno reagendo le università?
La guerra scoppiata nell’aprile 2023 ha messo a durissima prova le università sudanesi, soprattutto se consideriamo che oltre l’80% degli istituti di istruzione superiore si trova nella capitale, Khartoum, che è diventata uno dei principali teatri di guerra. Nei primi mesi del conflitto, queste istituzioni hanno sospeso completamente le attività, come del resto è accaduto in quasi tutti i settori del Paese. Docenti e studenti si sono trovati sfollati nel tentativo di mettersi in salvo oppure bloccati in zone di guerra, senza alcuna prospettiva chiara su come proseguire gli studi.
Nonostante la situazione drammatica, le università sudanesi hanno mostrato con determinazione di voler riprendere le attività accademiche. Grazie agli sforzi instancabili del personale amministrativo e del corpo docente, le attività educative sono riprese meno di sei mesi dopo lo scoppio della guerra. Le università che si trovano in stati relativamente più sicuri, come l’Università di Gezira, hanno ripreso le lezioni e ospitato sessioni d’esame di istituzioni basate in zone di conflitto.
All’Università di Khartoum, dove sono iscritta come dottoranda e insegno presso il Dipartimento di Archeologia, siamo riusciti ad organizzare una prima sessione di esami per i laureandi del quarto e quinto anno solo quattro mesi dopo l’inizio del conflitto, e quegli studenti si sono laureati regolarmente in tutte le facoltà. Successivamente è stata avviata la didattica a distanza per gli altri studenti, su varie piattaforme digitali. Tuttavia, a causa della debolezza e instabilità della connessione internet in molte aree del Paese, all’inizio è stato difficile standardizzare la modalità di insegnamento online.
In un secondo momento, però, l’Università di Khartoum è riuscita a organizzare altre quattro sessioni d’esame, ha lanciato una piattaforma e-learning dedicata alla didattica in tutte le facoltà e ha stretto accordi con altre università, istituzioni accademiche e ospedali situati in aree sicure dentro e fuori il Sudan. Queste collaborazioni hanno permesso di offrire agli studenti opportunità di formazione anche in Paesi come Egitto e Arabia Saudita, dove l’università ha istituito sedi d’esame.
Anche le procedure amministrative sono riprese in modalità telematica tramite i siti ufficiali dell’università, consentendo l’iscrizione ai programmi post-laurea, il rilascio di certificati e altri servizi accademici. Inoltre, il Graduate College ha organizzato esami e discussioni di tesi online per studenti e studentesse di master e dottorato, permettendo a molti di loro di conseguire il titolo nonostante la guerra.
Per quanto riguarda i danni subìti, le principali università di Khartoum – come l’Università di Khartoum, l’Università di Neelain, la Sudan University of Science and Technology, l’Università di Bahri e l’Università Islamica di Omdurman – hanno sofferto particolarmente. I loro campus sono diventati campi di battaglia e depositi di armi. Le infrastrutture sono state gravemente danneggiate, laboratori e aule sono stati saccheggiati e distrutti, perfino i banchi delle aule sono stati rubati o incendiati.
Nel Darfur, università come l’Università di Nyala e l’Università di Zalingei sono state quasi completamente distrutte; la sicurezza inesistente e il vandalismo sistematico hanno causato una totale interruzione delle attività accademiche.
Docenti, personale amministrativo e studenti, tuttavia, si sono battuti con straordinaria caparbietà per far proseguire le attività. Nonostante la devastazione e le difficoltà, tutte le università sudanesi – pubbliche e private – sono riuscite a riprendere le attività accademiche e a mantenere viva la missione dell’istruzione superiore nel Paese anche in condizioni straordinariamente difficili.
Desidero esprimere un sincero ringraziamento all’Università Ca’ Foscari Venezia e al programma Erasmus+ per avermi offerto questa opportunità in un momento così critico. Sono profondamente grata a tutte le persone che hanno reso possibile questa esperienza e spero che la collaborazione accademica tra le istituzioni sudanesi e italiane possa continuare a crescere, creando ulteriori opportunità di scambio e conoscenza reciproca.