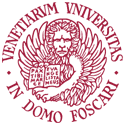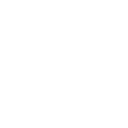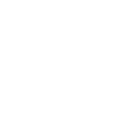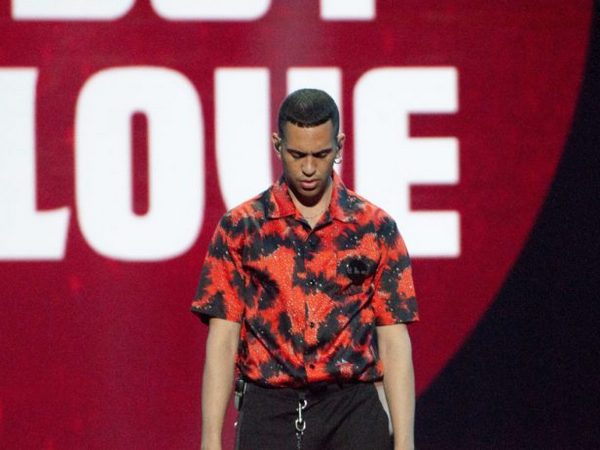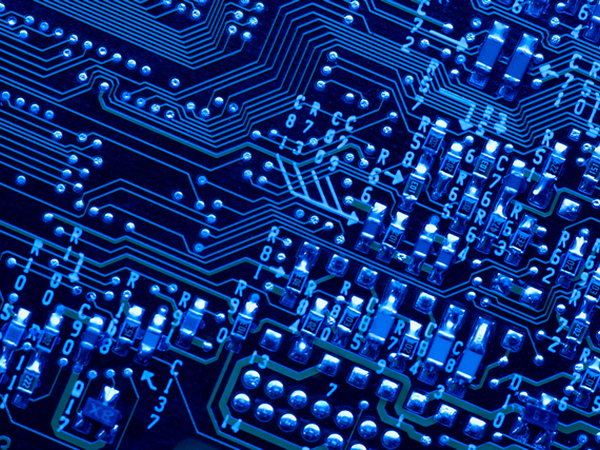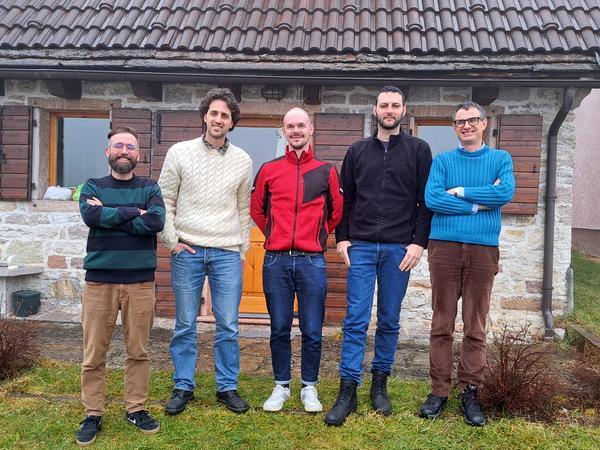Donne e deforestazione: il legame tra violenza ecologica e di genere nelle comunità indigene amazzoniche, secondo il progetto W-Deforest

Nel 2025 l’Amazzonia sarà al centro dell’attenzione globale nella lotta ai cambiamenti climatici. Per la prima volta, dal 10 al 21 novembre, il vertice mondiale sul clima (COP30) si terrà in Brasile, a Belém, nel cuore della foresta amazzonica.
Ma è nel sud del Perù, al confine con il Brasile, che si trova il Parque Nacional del Manu, una delle aree protette più vaste e ricche di biodiversità al mondo. Questo polmone verde, che copre circa un milione e mezzo di chilometri quadrati, ospita diverse comunità indigene appartenenti ai gruppi Matsiguenga, Arakmbut e Yine.
Anche qui la deforestazione avanza, spinta soprattutto dall’apertura di nuove strade tra Perù e Brasile e dalla crescente domanda di legname pregiato. In questo processo, oltre ai coloni andini, sono coinvolte anche alcune comunità indigene, attratte dalle opportunità economiche che queste attività offrono. In un contesto di forte marginalizzazione, dove mancano servizi essenziali come elettricità, acqua potabile, alimenti e cure mediche, la costruzione di strade da parte di imprese private rappresenta spesso l’unica alternativa concreta allo stallo dello Stato.
Tuttavia, questi progetti raramente seguono criteri ecologici o valutazioni d’impatto ambientale. In questo scenario instabile, segnato da conflitti tra poteri economici, anche le donne indigene giocano un ruolo, spesso invisibile. Spinte dalla necessità di garantire un futuro ai propri figli, molte assumono ruoli professionali in contesti lavorativi precari e violenti, cercando di emanciparsi dalla povertà pur consapevoli dei danni ambientali che ne derivano.
Da questa realtà nasce il progetto W-Deforest, dell’antropologa Silvia Romio, che ha scelto l’Università Ca’ Foscari per condurre il suo progetto di ricerca con finanziamento Marie-Curie. Il progetto esplora il legame tra genere, violenza e tensioni ambientali, sfidando la visione idealizzata delle donne indigene come unicamente custodi della foresta. Romio sottolinea come la complessità delle loro esperienze, spesso segnate da violenze strutturali, influenzi profondamente il loro rapporto quotidiano con la foresta, principale fonte di sostentamento. “Sebbene la maggior parte dei canali d’informazione legati alle popolazioni indigene amazzoniche sia solito dipingere le donne indigene come la massima espressione della difesa dei boschi primari – ci ha spiegato l’antropologa - chi frequenta direttamente questi ambienti sa bene che le cose sono più complesse e problematiche. Spesso, non così scontante o lineari. Inoltre, gli studi che hanno affrontato la dimensione della violenza strutturale di genere tra le donne indigene sono estremamente rari, e nessuno ha mai approfondito le conseguenze che questa esperienza può avere nel rapporto quotidiano di queste donne con i propri mezzi di sussistenza, in primo luogo la foresta che le circonda.”
Grazie alle tecnologie offerte dalle Digital Humanities, il podcasting costituirà l’output principale del progetto, ma non l’unico. W-Deforest adotterà gli strumenti teorici e pratici forniti dalla psicologia comunitaria per facilitare una riflessione e una narrazione collettiva sulle condizioni lavorative e sulle questioni economiche ed emotive quotidiane che caratterizzano il vissuto di un gruppo di donne indigene, che vivono all’entrata del Parque Natural del Manu. Tra i vari strumenti considerati, ci sono le mappe parlanti (mappe alimentate liberamente da disegni personali, racconti e informazioni private delle partecipanti) e gli autoritratti collettivi (disegni autorappresentativi utilizzati per illustrare i diversi stati d’animo e status sociali delle partecipanti).
In che zona e su quali comunità si concentrano i suoi studi? Qual è il contesto ambientale e sociale?
Sebbene nell'immaginario collettivo — soprattutto europeo — il Perù sia spesso associato alle Ande, è importante ricordare che oltre il 60% del suo territorio è coperto dalla foresta amazzonica. Quest’ampia regione ospita un numero significativo di popolazioni indigene, la cui entità esatta è difficile da determinare. Si stima che queste comunità appartengano a più di cinquanta gruppi etnici, appartenenti a differenti famiglie linguistiche; alcune vivono in isolamento volontario.
La maggior parte delle popolazioni indigene conosciute risiede oggi all’interno di “comunità native”, strutturate in villaggi composti da nuclei familiari estesi, e detiene diritti di proprietà su porzioni più o meno ampie di territorio.
A livello statale, il Perù riconosce i diritti territoriali delle popolazioni indigene quando queste, organizzate per famiglie, riescano a dimostrare una residenza stabile e l’uso continuativo delle terre in una determinata area. Per questo motivo, in una stessa regione possono coesistere comunità native appartenenti a gruppi etno-linguistici diversi, distinguibili per lingua, usi, costumi e tradizioni.
Da antropologa, conduco da anni ricerca sul campo in questo territorio, in particolare sui gruppi etno-linguistici degli Jibaro e degli Arawak: ho infatti condotto per quasi dieci anni una ricerca tra gli Awajún della regione Amazonas, e dal 2022 mi dedico a delle comunità Arakmbut e Yine presenti nella regione Madre de Dios.
Per il progetto W-Deforest sono tornata a lavorare nel cuore dell'Amazzonia peruviana, con la popolazione Yine (chiamata anche Piro), appartenente alla famiglia linguistica Arawak, che oggi sta scomparendo. Si contano infatti poche centinaia di individui a causa di eventi storici e sociali dell’ultimo secolo. Uno su tutti, il commercio del caucciù, all’inizio del XX secolo, per il quale gli impresari sfruttavano la manodopera di gruppi indigeni storicamente pacifici, come il caso degli Yine, innescando profondi cambiamenti sociali e generando rivalità interne e disfacimento dell'identità etnica come strategia di sopravvivenza.
Da tradizione, l’economia degli Yine si basa sulla pesca e sull'agricoltura, pratiche che - a quanto pensavo nei primi tempi della mia ricerca - dovrebbero costruire un profondo legame tra le persone e l'ecosistema fluviale e forestale. Mi aspettavo quindi di incontrare comunità innamorate del loro territorio, che tutelano l’ambiente in sintonia con le politiche ed i progetti delle organizzazioni internazionali che si occupano di conservazione ambientale. In realtà, ho constatato come la contemporaneità abbia introdotto nuove dinamiche, determinate spesso dal prezzo delle materie prime nel mercato internazionale, oltre che dalle insufficienti politiche statali di sostegno. Di fatto, questi gruppi sono carenti di tutti i servizi basici (acqua potabile, luce e gas, assistenza medica ecc…) e sono costrette a comprare cibo, utensili o medicine al mercato nero locale, che presenta prezzi altissimi. Questa situazione ha, nel tempo, generato un’immensa insoddisfazione, a volte anche un sentimento di rabbia e tensione, verso le politiche ambientali di conservazione, percepite spesso come ingiuste e svantaggiose nei loro confronti.
In che modo la violenza storica e strutturale che subiscono le donne indigene incide sul loro rapporto con l’ambiente, e che ruolo hanno nei processi di deforestazione?
Il mio progetto, avviato nel 2022, ha focalizzato l'attenzione sulla regione di Madre de Dios. L'obiettivo primario era investigare le risposte di alcune comunità indigene, che vivono nella zona di accesso al Parco Natural del Manu, alla crisi pandemica di COVID-19. La vita socioeconomica e culturale di queste comunità è indissolubilmente legata a una strada marginale, che agisce come una vera e propria arteria vitale, e che durante il periodo del Covid venne ampliata sotto una forma di ‘autogoverno’ locale. Non si tratta solo di un'infrastruttura, ma è il mezzo attraverso cui queste popolazioni si connettono con l'esterno, garantendo l'accesso a beni essenziali e, al contempo, commercializzando i loro prodotti. Nelle ultime elezioni amministrative, avvenute nell’ottobre del 2022, la maggior parte dei voti sono stati a favore del candidato che promuoveva la deforestazione a favore delle strade. Ma il rapporto tra gli indigeni e la strada è di lunga data.
Fino agli anni Novanta, l'economia locale nella regione di Madre de Dios era dominata dal commercio del legname pregiato, una fonte di reddito vitale per le comunità. Questa economia, tuttavia, è stata bruscamente interrotta con l'istituzione delle aree protette, una misura di conservazione che ha inavvertitamente impoverito le popolazioni autoctone. Il divario tra l'economia locale e il costo dei beni essenziali, come il carburante e il gas, ha reso la vita quotidiana insostenibile: l'acqua potabile dipende dalla bollitura, che richiede gas, e la mobilità fluviale, cruciale per il commercio e gli spostamenti, necessita di benzina, entrambe risorse inaccessibili. A differenza delle strade, inoltre, il fiume si rivela una via di collegamento precaria e spesso pericolosa.
Le soluzioni proposte, come il commercio di artigianato sponsorizzato dalle organizzazioni di conservazione, si sono dimostrate fallimentari e insufficienti. In questo contesto di precarietà, il mio lavoro di ricerca ha rivelato una realtà che non era mai stata studiata: l'emergere di una imprenditorialità femminile nel trasporto e nel commercio del legname. In una società storicamente patriarcale, le donne si sono ritagliate ruoli chiave, dimostrando una notevole iniziativa e capacità gestionale.
Questa dinamica assume un significato particolare in un territorio di frontiera, dove lo Stato è assente e la sicurezza è compromessa dalla crescente presenza del narcotraffico. Le reti criminali, anche loro interessate alla costruzione di strade, instaurano accordi con le comunità indigene. In questo scenario, le donne sono costrette a ritagliarsi uno spazio di sopravvivenza in bilico tra forze contrastanti: la società patriarcale, la violenza dei narcotrafficanti, le proposte delle ONG e la necessità di generare un guadagno.
Questa realtà sfida la narrazione dominante che ritrae le donne indigene unicamente come custodi di rituali, delle tradizioni e dell'ambiente. Pur non negando l'importanza di questi ruoli, emerge un'altra dimensione: quella di donne che lavorano per la sopravvivenza in un mondo prevalentemente maschile e spesso violento, dove la violenza domestica e sessuale è una triste normalità. La consapevolezza di questa complessità mi ha spinto a riconoscere i limiti dei classici strumenti etnografici e a ripensare radicalmente il mio approccio metodologico, al fine di cogliere appieno queste sfumature e contraddizioni.
Come si applicano i metodi della psicologia comunitaria al suo contesto di studi, e con quali obiettivi? In che modo il podcast, come formato narrativo e partecipativo, può arricchire la ricerca sociale?
L’obiettivo è capire cosa spinge le donne indigene ad appoggiare il progetto di deforestazione, considerando le loro esperienze di violenza storica e di genere.
Ho cercato diverse zone di interazione, in collaborazione con un team di psicologhe esperte in tema di violenza di genere, mondo indigeno e sintomi post-traumatici. In questo contesto, la violenza subìta non viene verbalizzata, raccontata. I motivi sono molteplici, e vanno dal gap linguistico alla scarsa abitudine a parlare di sé. Esiste tuttavia una serie di strumenti - come i disegni, le canzoni, le talking maps e gli autoritratti – oggi utilizzati dalla psicologia comunitaria, che mirano a lavorare in maniera diversa, utilizzando la dimensione collettiva, e stimolando nuove forme di consapevolezza e di empowerment. Le donne, poco a poco, acquistano una narrativa e una consapevolezza delle loro risorse e strategie di lotte per la sopravvivenza, nutrendo allo stesso tempo nuovi strumenti di auto-narrazione e autostima. La condivisione delle esperienze traumatiche stimola la nascita di reti di solidarietà e la consapevolezza che la violenza si può superare insieme.
Ho in programma due diversi periodi di ricerca in Perú: dopo un primo lavoro sul campo, ho programmato una seconda fase del progetto, in cui mi dedicherò ad analizzare con le donne indigene coinvolte nel progetto i primi risultati della ricerca. Sarà in questo dialogo, fatto di disegni, racconti e biografie, oltre che di esperienze vissute assieme, che potranno emergere molteplici letture del territorio e di trasformazioni sociali e ambientali vissute. Prospettive e sensibilità quindi che non avremmo mai raggiunto attraverso il dialogo e l’intervista nel senso classico della metodologia etnografica. Ed è proprio da questo dialogo che conto di elaborare il materiale audio utile per il futuro podcast.
La sua ricerca si concentra in una zona di frontiera tra Perù e Brasile. Trova difficoltà durante le indagini sul campo?
Essere donna ed europea, in un contesto come questo, può significare una maggiore vulnerabilità. Gli spostamenti, spesso lunghi e complicati, sono rischiosi, a causa degli incidenti, ma anche di attacchi da parte di narcotrafficanti, un problema diventato più acuto durante la pandemia, quando controlli e sorveglianza si sono notevolmente ridotti. La comunità in sé è un luogo sicuro, ma la presenza dei narcos nei territori circostanti rappresenta un pericolo concreto con cui fare i conti.