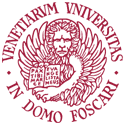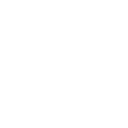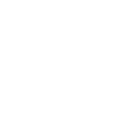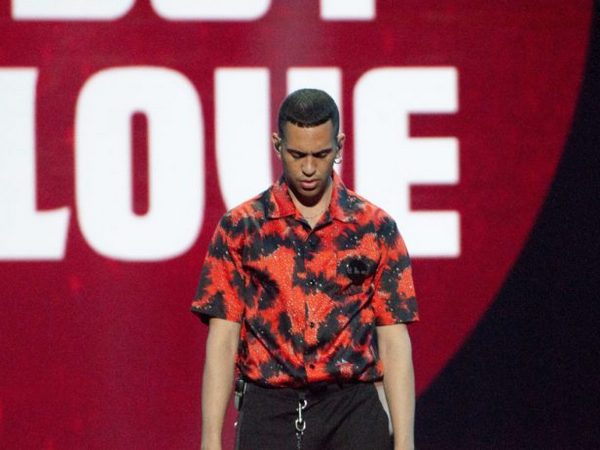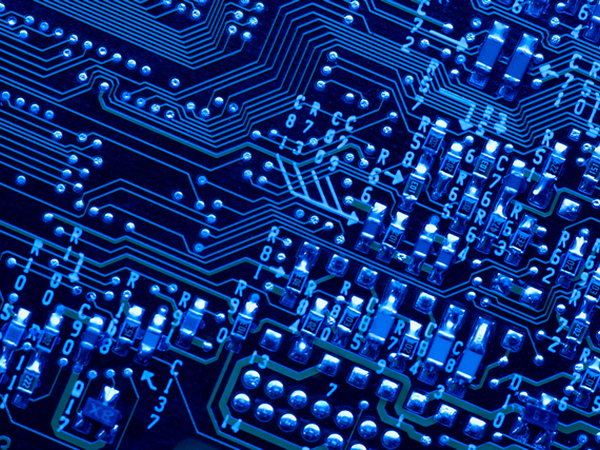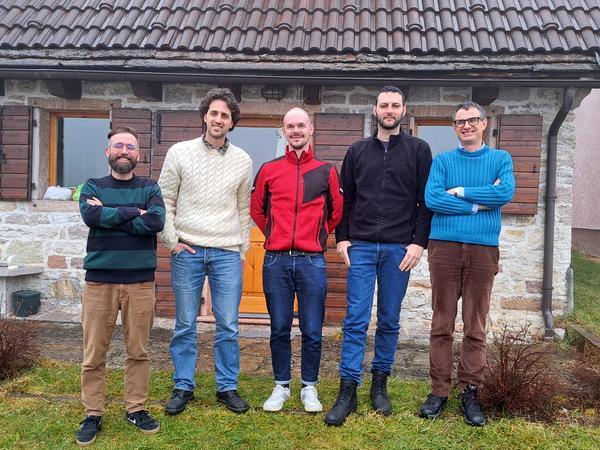(Ri)pensare la vulnerabilità come strumento di trasformazione sociale: il progetto VULNAT

Come può la filosofia aiutarci a capire la vulnerabilità che attraversa le nostre società? Ripensare il concetto di vulnerabilità può contribuire a trasformare il mondo in cui viviamo? Da queste domande nasce VULNAT – Transactional Life and Vulnerability. A Bio-Social Account of Vulnerability for the Critique of Intersectional Social Pathologies, progetto Seal of Excellence - Young Researcher finanziato dall’Unione Europea, ospitato dall’Università Ca’ Foscari Venezia e supervisionato dalla dott.ssa Francesca Sofia Alexandratos.
In un’epoca segnata da crisi sociali, politiche e ecologiche, VULNAT invita a riscoprire la vulnerabilità come dimensione della vita e origine di trasformazione sociale, coniugando la riflessione sociale e politica con una rinnovata attenzione alla dimensione umana della fragilità.
“Dall’inizio del mio percorso mi sono occupata di teoria critica, quella branca della filosofia che si interroga sulla capacità delle società di assicurare una vita riuscita agli esseri umani”, spiega la ricercatrice. “In specifico, mi interessava capire come il riconoscimento reciproco tra soggetti potesse costituire la condizione di possibilità per il rafforzamento della relazione vitale tra individuo e ambiente. Durante il dottorato ho quindi lavorato su due tradizioni filosofiche che si occupano di questo tema: la Scuola di Francoforte, in particolare Axel Honneth, e il pragmatismo americano di John Dewey”.
Proprio nel dialogo tra queste due tradizioni viene individuata la radice del progetto: “Lo studio a cavallo tra queste prospettive è stato per me un momento decisivo. In Dewey ho trovato una riflessione preziosa sul concetto di natura e di natura umana, che comprende la continuità e l’interdipendenza tra organismi umani e non umani e riconosce le potenzialità etiche e critiche di questa relazione verso i contesti sociali.”
Dopo il dottorato, un periodo di insegnamento a Ca’ Foscari e un’esperienza post-doc in Portogallo hanno contribuito a definire meglio la direzione del lavoro. “VULNAT prosegue il percorso che avevo iniziato, ma si concentra sul concetto di vulnerabilità, tradizionalmente intesa come la condizione degli esseri umani di essere esposti alla sofferenza in virtù della loro relazione con l’ambiente”.
La vulnerabilità da condizione di passività a motore di cambiamento
Il progetto mira a costruire una concezione filosofica della vulnerabilità che sia, nelle parole della ricercatrice, “ambivalente e plurale”. “Spesso”, spiega, “si tende a pensare la vulnerabilità solo come una condizione di passività. Ma, come hanno messo in luce filosofe e filosofi critici, questa visione rischia di generare nuove forme di potere: i soggetti considerati ‘non vulnerabili’ finiscono per decidere che cosa sia meglio per quelli ‘vulnerabili’, alimentando relazioni che possono diventare oppressive. La vulnerabilità va pensata quindi anche nella sua dimensione attiva, come capacità critica e trasformativa. La sofferenza e la dipendenza non sono solo condizioni da cui difendersi, ma possono diventare strumenti per comprendere e cambiare la realtà sociale”.
Al giorno d’oggi, la vulnerabilità è una condizione pervasiva: “È presente nei rapporti di lavoro, nei sistemi economici, nei processi coloniali ancora attivi, nelle crisi ambientali e nei conflitti. È una condizione esistenziale, ma anche un effetto delle strutture sociali. Ripensarla significa capire cosa non funziona nelle nostre società e restituire voce ai soggetti che più di altri ne portano i segni”.
Il valore politico e umano di VULNAT sta proprio in questa inversione di prospettiva: non guardare la vulnerabilità come un difetto da correggere, ma come una condizione costitutiva dell’esistenza e come motore di cambiamento. “Il mio obiettivo non è proporre una teoria di tutte le forme di oppressione possibili”, continua Alexandratos “ma offrire uno strumento teorico elastico, che possa essere utilizzato nei contesti più diversi. Credo che i veri teorici critici siano i soggetti vulnerabili stessi: sono loro che, vivendo l’esperienza della vulnerabilità, possono aiutarci a vedere la realtà in modo nuovo ed elaborare prospettive originali sulle strutture di potere”.
L’obiettivo del progetto di ricerca è quindi quello di delineare una teoria capace di intendere la vulnerabilità come processo vitale, cogliere ciò che accomuna le vulnerabilità in quanto processi in cui passività e attività coesistono, distinguere diverse ‘specie’ di vulnerabilità sulla base delle declinazioni di questa co-esistenza, e rendere conto del pluralismo delle ‘forme’ di vulnerabilità che emergono, a seconda delle posizioni dei soggetti e dei gruppi nel contesto sociale. «Voglio rendere conto della pluralità delle vulnerabilità e del modo in cui esse si intersecano. Negli ultimi anni stiamo assistendo alla nascita di movimenti sociali intersezionali - femministi, antirazzisti, ecologisti - che si incontrano e si riconoscono come portatori di forme di vulnerabilità differenti ma connesse. La filosofia può aiutarci a trovare un linguaggio condiviso per comprendere questa pluralità, senza ridurla a un’unica categoria astratta».
Intersezionalità, ‘patologie sociali’, relazioni di cura: lo sviluppo del progetto
La lente teorica scelta per elaborare questa prospettiva è il pragmatismo, in particolare quello di Dewey e di due figure femminili a lungo dimenticate e oggi oggetto di rinnovata attenzione: Mary Parker Follett e Jane Addams. “Il pragmatismo americano ci offre una concezione del rapporto tra organismo e ambiente che è transazionale. C’è una circolarità reciproca: non è solo l’ambiente a determinare l’individuo, ma è anche l’individuo che trasforma l’ambiente. Questo concetto di transactional life ci permette di pensare la vulnerabilità non come una condizione statica, ma come un processo vitale in cui passività e attività, sofferenza e resistenza si intrecciano”.
Questa concezione, che si oppone al mito moderno dell’individuo autosufficiente e razionale, mette al centro la dimensione relazionale dell’esistenza. “Per secoli ci siamo raccontati che l’individuo è padrone di sé e che se fallisce è solo colpa sua”, osserva. “Ma la realtà è che le persone vivono all’interno di strutture sociali, economiche e ambientali che possono favorire o impedire la loro autorealizzazione. La vulnerabilità ci costringe a riconoscere queste dipendenze e a interrogarci sui limiti della nostra autonomia. È anche uno strumento epistemico: attraverso la sofferenza comprendiamo che qualcosa non funziona nella nostra vita o nella società. E da lì può nascere la spinta alla trasformazione”.
E le società, proprio come gli organismi, possono ammalarsi: “Si parla di ‘patologie sociali’ quando le relazioni di riconoscimento tra individui umani e le interazioni vitali con l’ambiente si irrigidiscono, perdono la loro ambivalenza di reciproca passività e trasformazione, diventando fonte di oppressione. Le oppressioni di genere, le disuguaglianze economiche, la distruzione ecologica sono patologiche in quanto interrompono i diversi livelli di circolarità alla base della vita”.
Nel suo approccio, Alexandratos combina diversi metodi: la ricostruzione concettuale delle categorie di vulnerabilità, transazione vitale, natura, potere, riconoscimento e cura, e il dialogo con altre discipline come l’antropologia filosofica. Nel corso di tre anni, VULNAT si svilupperà attraverso fasi distinte. “Il primo anno è stato dedicato alla ricostruzione del concetto di transactional life nella tradizione pragmatista”, spiega la ricercatrice. “Dal secondo anno mi concentrerò sulla teoria intersezionale, che aiuta a comprendere come le diverse forme di potere e livelli di oppressione si sovrappongono. Infine, durante il terzo anno andrò ad analizzare criticamente le relazioni di riconoscimento e cura tra e verso soggetti vulnerabili, cercando di comprendere quali condizioni sono necessarie affinché non diventino relazioni oppressive o ideologiche.”
Il progetto prevede anche una serie di attività pubbliche e collaborative. “Sto organizzando una serie seminariale dedicata alle donne pragmatiste, un workshop internazionale che si terrà a marzo e, insieme a Radio Ca’ Foscari, un podcast che racconterà il percorso del progetto e le sue riflessioni”.