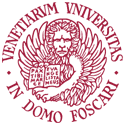Giovanni Costa, Università degli Studi di Padova
A cura di VSM Alumni, luglio 2025

Formare manager consapevoli in un mondo che cambia
Professore emerito di Strategia d’impresa e Organizzazione aziendale all’Università di Padova, Giovanni Costa è tra le figure più influenti della cultura economico-manageriale italiana. Con una lunga carriera accademica che lo ha portato a insegnare, tra le altre, a SDA Bocconi, al CUOA di Vicenza, alla ESSEC di Parigi e all’Università Ca’ Foscari Venezia, ha saputo intrecciare didattica, ricerca e dialogo con le imprese, contribuendo allo sviluppo del pensiero strategico in Italia e alla formazione di generazioni di imprenditori e manager.
È stato prorettore ai rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie all’Università di Padova e ha ricoperto importanti ruoli di governance, tra cui la vicepresidenza del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo e la presidenza della Cassa di Risparmio del Veneto.
Socio di prestigiose accademie quali la Galileiana, l’Olimpica, e socio onorario di AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale), editorialista del Corriere del Veneto, è stato anche uno dei protagonisti della nascita del percorso in Economia Aziendale a Venezia, che oggi vive nuova linfa attraverso la Venice School of Management.
In questa intervista, il professore ripercorre le origini di quella visione pionieristica, riflette sull’evoluzione delle competenze manageriali, e lancia uno sguardo lucido e ispirato sul futuro delle scuole di management.
Professore, lei ha dato un contributo fondamentale alla nascita e allo sviluppo del percorso di studi in Economia aziendale a Venezia. Ci racconta com’è nato questo progetto e quale era la visione che lo guidava?
Il progetto veneziano fu fermamente voluto da Pasquale Saraceno (1903-1991) che, pur provenendo da un’esperienza legata alle grandi imprese aveva colto l’esigenza di creare una scuola per il management del nascente miracolo delle PMI del Nord Est. Fu un’operazione con forte valenza tecnica, ma attenta anche alla dimensione culturale. Saraceno volle, per esempio, che metà degli insegnamenti fosse di natura non tecnica. Quello spirito è cresciuto negli anni ispirando sia le pratiche operative che la riflessione teorica.
Nella tradizionale impostazione delle facoltà di Economia e Commercio, l’aziendalismo si basava essenzialmente sulla ragioneria che costituiva il nocciolo duro della professione del dottore commercialista. L’eccezionale sviluppo imprenditoriale affermatosi in Italia nel secondo dopoguerra e l’apertura internazionale della nostra economia avevano stimolato il gruppo di giovani raccolti attorno a Pasquale Saraceno a misurarsi con altri approcci e altri strumenti in grado di integrare la dimensione economico-finanziaria con quella manageriale. La sfida consisteva nel metabolizzare rapidamente l’esperienza nord americana facendola interagire con le specificità del nostro tessuto imprenditoriale e con i forti stimoli al cambiamento che provenivano dal mondo giovanile.
La visione della scuola veneziana può essere sintetizzata nei seguenti punti:
- la centralità teorica e pratica dell'impresa e dell’imprenditore;
- il riconoscimento del ruolo attivo che devono avere le istituzioni per un corretto funzionamento del mercato e per la correzione delle sue distorsioni;
- un pluralismo teorico che non scade mai nell’eclettismo;
- l'attenzione alla molteplicità di attori interessati ai destini dell'azienda;
- il ruolo del management professionale nella razionalizzazione delle decisioni d'impresa;
- la costante attenzione al ruolo dei sistemi-Paese e delle loro aggregazioni nella creazione del vantaggio competitivo delle imprese e delle nazioni.
In un mondo accademico e aziendale in continua evoluzione, quali competenze ritiene oggi imprescindibili per chi si forma in Management?
In un mondo percorso da continui cambiamenti quello che è destinato a permanere non sono le soluzioni tecniche contingenti ma il metodo con cui si affrontano i problemi. E il metodo che deve qualificare il management è interdisciplinare. Le competenze tecniche sono ormai date per scontate. Ciò che fa la differenza sono le meta-competenze cioè la capacità di rigenerare le competenze e trovare nuove soluzioni a nuovi problemi.
Quali sfide e opportunità vede oggi per una scuola di Management come la nostra, chiamata a formare i leader del futuro in un contesto globale sempre più complesso?
Una scuola di Management collocata in una città aperta all’internazionalità, carica di storia, di valori, di bellezza, e integrata in una regione che costituisce un laboratorio a cielo aperto di innovazione e imprenditorialità è in una posizione ideale per parlare al mondo. Deve solo volerlo fare, con determinazione.
Nel suo percorso accademico ha intrecciato didattica, ricerca e dialogo con le imprese. Quanto è importante, secondo lei, mantenere questo equilibrio anche nella formazione manageriale di oggi?
Nella formazione manageriale, oggi come allora, mi sono sempre ispirato alla convinzione che una buona ricerca deve produrre una buona didattica e che entrambe sono tali se contribuiscono alla crescita e all’evoluzione delle imprese.
Se dovesse dare un consiglio alle nuove generazioni di studenti e neolaureati della VSM, quale sarebbe?
Essere pronti a sviluppare senza esasperazioni il principio di specializzazione, essere flessibili, capaci di muoversi rapidamente e ricombinare le proprie capacità, aperti alle culture e alle idee degli altri, disponibili ad apprendere da esse e a mettere in discussione il primato delle proprie. Prepararsi a sfruttare i cambiamenti tecnologici e le crisi ricorrenti per ripensare i modelli di management, rivedere gli strumenti gestionali, interpretare nuovi ruoli.
C’è un momento, un ricordo o un progetto legato alla sua esperienza a Venezia, in quello che era il dipartimento di Economia e direzione aziendale oggi Venice School of Management, che porta con sé con particolare orgoglio?
Tra i molti ricordi trovo particolarmente significativo il percorso che portò nel 1995 al conferimento, promosso dal nostro dipartimento, della laurea honoris causa in Economia aziendale a Luciano Benetton e Leonardo Del Vecchio (1995), imprenditori di prima generazione che hanno creato dal nulla due realtà studiate e ammirate in tutto il mondo.
Con uno sguardo lucido, profondo e sempre aperto al cambiamento, Giovanni Costa ci ricorda che la formazione in ambito manageriale non può limitarsi all’apprendimento tecnico, ma deve fondarsi su un equilibrio dinamico tra cultura, impresa, contesto e metodo.
In un’epoca segnata da trasformazioni rapide e continue, la sua testimonianza rappresenta un invito potente a formare leader capaci di unire pensiero critico e spirito pratico, competenze solide e capacità di reinventarsi, radicamento nei territori e apertura internazionale. Una lezione preziosa per chi, oggi, attraversa le aule della Venice School of Management con il desiderio di lasciare un segno nel mondo.