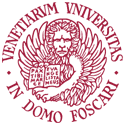Serena Ricci, Quacquarelli Symonds (QS)
A cura di VSM Alumni, settembre 2025

Business school di domani con radici a Venezia
Dopo la laurea in Economia Aziendale a Ca’ Foscari, e dopo aver contribuito a creare e far crescere i Reimagine Education Awards & Conference, Serena Ricci ha costruito una carriera all’intersezione tra storytelling, strategia di crescita, dati e partnership internazionali, e oggi ricopre il ruolo di Growth Marketing Manager in QS, società globale di analisi e servizi per l’istruzione superiore, nota per i QS World University Rankings e per piattaforme ed eventi che collegano studenti e atenei.
Il suo percorso, arricchito anche da esperienze con UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) e da un impegno nel Learning Committee di OpenUK - la no-profit che rappresenta l’ecosistema dell’open technology nel Regno Unito (open source software, open data, open hardware)— dimostra come la formazione in management a Venezia possa diventare il trampolino verso una carriera globale. Guardando al futuro delle business school, Serena porta con sé una prospettiva che intreccia competenze quantitative, cultura internazionale e una costante attenzione all’impatto sociale e alla sostenibilità.
Guardando al tuo percorso professionale, quali sono stati i passaggi chiave dopo la laurea in management a Ca’ Foscari, che ti hanno portata fino a QS?
Mi sono laureata a Luglio 2015 in Economia Aziendale – Economics & Management con l’idea chiara di costruire un profilo “spendibile” all’estero: corsi in inglese, base quantitativa solida, molta pratica sulla comunicazione.
Le tappe chiave che mi hanno portato a QS, in realtà, sono iniziate ben prima della laurea – e sono il principale motivo per cui ho trovato lavoro velocemente. L'Ufficio Stage & Placement dell’Ateneo è stato un punto di riferimento per costruire il mio profilo professionale, sin dai primi anni di studio a Ca' Foscari. Già nell’estate 2014 avevo fatto un tirocinio a Londra in International Marketing presso Raglan International, una Start-Up attiva nel settore luxury services & real estate, quello è stato il primo “timbrino” UK sul CV e, soprattutto, il test per capire che volevo crescere in un ambiente internazionale.
Nel Maggio 2015, mentre preparavo la tesi, ho partecipato a 'Let's Brand', laboratorio su personal branding, social media e web reputation, grazie al quale mi sono avvicinata al mondo del Branding. Successivamente sono stata selezionata per il corso “Brand Manager Specialist”, organizzato in collaborazione con la Regione Veneto. Questo percorso, che affiancava alla formazione in aula 400+ ore di tirocinio presso una delle aziende partner, è stato il mio punto di contatto con l'azienda per cui tutt'oggi lavoro, QS Quacquarelli Symonds.
In QS sono entrata nel team Comunicazione & PR lavorando sulla seconda edizione dei Wharton–QS Reimagine Education Awards & Conference. È stato un battesimo del fuoco: brand, storytelling, media relations, CRM, community building e delivery dell’evento, fino a farlo crescere negli anni da 300 a 900-1000 delegati (a Dicembre 2025 ci sarà la 12ª edizione). Quell’esperienza mi ha dato due lezioni: la prima è l’ownership—quando costruisci qualcosa end-to-end impari più in un anno che in tre ruoli iper-specialistici; la seconda è che anche nella comunicazione devi parlare la lingua dei dati: lead generati, tassi di conversione, retention di partner e partecipanti. Da lì il passaggio è stato naturale: ho assunto il ruolo di Product Marketing Manager per il portafoglio di thought leadership (conferenze e pubblicazioni), definendo posizionamento, messaggi e go-to-market, e poi sono approdata al ruolo attuale di Growth Marketing Manager, dove unisco narrativa, canali e sperimentazione continua su funnel, pricing/packaging e partnership. In retrospettiva, i passaggi chiave sono stati tre: scegliere ruoli “a T” (profondità nel marketing, curiosità per prodotto e vendite), chiedere responsabilità reali molto presto e legare ogni attività a una metrica comprensibile al business.
Quali competenze o attitudini, sviluppate durante gli anni di studio a Venezia, ti hanno aiutata di più a posizionarti come professionista a livello internazionale?
Ca’ Foscari mi ha allenata su qualcosa che nel marketing internazionale vale oro: la data literacy applicata. Statistica, metodi quantitativi e accounting mi hanno abituata a formulare ipotesi, misurarle e prendere decisioni. Tradotto: so leggere un funnel, impostare un A/B test sensato e spiegare perché scelgo una variante allineandola a obiettivi e vincoli. A questo si aggiunge la scrittura chiara in contesti cross-culturali: corsi in inglese e classi miste mi hanno costretta a semplificare senza banalizzare, utile quando parli con rettori, product manager e partner in fusi orari diversi. Infine, la vita universitaria—associazioni, progetti, scadenze—mi ha dato project management con risorse limitate: priorità nette, pochi deliverable ben fatti e la capacità di “spedire” entro una data.
Se guardo agli strumenti che oggi consiglierei a chi vuole spingere sull’acceleratore: una base solida in Excel/Sheets (pivot e XLOOKUP), un’infarinatura di SQL e GA4 per non essere dipendenti dagli altri, familiarità con un CRM come HubSpot o Salesforce per capire davvero cosa succede alla domanda generata, e principi di SEO/AEO on-page e copywriting orientato ai segmenti (Jobs-to-Be-Done aiuta molto). L’AI infine è un moltiplicatore: la uso per ricerca preliminare, outline, quality check dei contenuti e come sparring partner creativo—ma verifico sempre fonti, numeri e coerenza con il brand.
Cosa rende secondo te una business school davvero competitiva e attrattiva a livello globale?
Dipende in parte dall’identità della scuola e dalla sua strategia di differenziazione, ma nella maggior parte dei casi l’attrattività si misura sul valore effettivo generato per lo studente. Gli elementi che contraddistinguono una business school davvero competitiva e internazionale includono: un ambiente accogliente per gli studenti internazionali accompagnato da un autentico impegno verso la diversità; l’accessibilità economica, o quantomeno la percezione di accessibilità, attraverso rette sostenibili, borse di studio e agevolazioni; un livello accademico rigoroso che combini teoria e pratica; partnership solide con datori di lavoro desiderabili; risultati occupazionali robusti e traiettorie di carriera convincenti per i laureati; una reputazione fondata su una cultura studentesca positiva e su docenti e staff realmente coinvolti.
Nel tuo lavoro hai una visione privilegiata sulle tendenze della formazione: quali sono le sfide e le opportunità principali che vedi per le business school nei prossimi anni?
Esistono numerose ricerche su ciò che preoccupa e guida oggi i dean delle business school. Le tendenze e le sfide che esperti di business schools come la mia collega Michelle Wieser (GME proposition lead) osservano sono, in realtà, opportunità per le scuole che scelgono di affrontarle in modo proattivo.
La prima riguarda l’erosione della percezione di valore del titolo: per attrarre studenti, le scuole devono mettere in evidenza il ROI dei programmi, altrimenti rischiano di perderli a favore di altri percorsi accademici o di metodi alternativi di apprendimento.
La seconda è il calo delle immatricolazioni in alcuni mercati, dovuto a demografia e preferenze in cambiamento, a cui si aggiungono variabili geopolitiche: rimanere competitivi significa lanciare i programmi e le credenziali giuste nei formati giusti.
Terzo tema: il curriculum. Il ritmo dell’innovazione tecnologica e l’evoluzione della domanda dei datori di lavoro impongono di integrare la tecnologia e mantenere i contenuti aggiornati, dotandosi anche di processi interni che permettano modifiche rapide a learning outcomes e syllabus.
Quarto: la reputazione. In un mercato globale, gestirla attivamente è cruciale: chi vuole attrarre studenti internazionali deve saper interpretare e comunicare le valutazioni terze della propria qualità, ma anche posizionare con chiarezza ciò che rende la scuola unica. Infine, impatto sociale e sostenibilità: sono temi centrali per studenti e aziende. Le scuole che sapranno intrecciare l’ESG nei programmi e nei corsi saranno percepite come più rilevanti e ad alto impatto.
Quanto è importante, dal punto di vista di QS, il ruolo della community alumni nella crescita e nel posizionamento di una business school come VSM?
La community alumni è essenziale per la crescita, il posizionamento e la vitalità di una business school. Gli alumni sono spesso i primi ambasciatori dei programmi e rappresentano un ponte vivo tra la scuola, i potenziali studenti e i datori di lavoro. Sul fronte recruiting, il loro coinvolgimento è decisivo per la stabilità e la crescita delle iscrizioni: possono segnalare candidati, condurre colloqui di ammissione, intervenire come speaker o panelist agli eventi, e raccontare la propria esperienza—soprattutto in termini di avanzamento di carriera—attraverso blog, social e altre forme di outreach, generando fiducia presso i prospect. Nella mentorship e nel supporto agli studenti, l’esperienza professionale degli alumni è un capitale prezioso: possono agire come mentori individuali o di gruppo, come ospiti in aula, come giudici di presentazioni o persino come promotori di case study “live”, portando in classe problemi reali e rendendo l’apprendimento più esperienziale. Sul versante occupazionale, gli alumni facilitano tirocini e placement, offrono coaching di carriera, ospitano visite aziendali e conducono mock interview; tutto ciò contribuisce a studenti meglio preparati e a outcome occupazionali più forti, rafforzando ulteriormente la reputazione della scuola. Infine, anche la formazione continua passa dagli alumni: certificati post-laurea, executive education e percorsi di sviluppo professionale dedicati a profili più esperti possono riportarli in aula e aprire nuove linee di ricavo. Qualunque sia la strategia di ingaggio, va ricordato che il rapporto è bidirezionale: gli alumni sostengono la scuola, ma la scuola deve sostenere gli alumni—con servizi di career coaching, workshop o seminari gratuiti—alimentando così un circolo virtuoso di valore condiviso.
Che consiglio daresti a chi si laurea con VSM e che oggi guarda al futuro con ambizione ma anche un po’ di incertezza?
Il primo consiglio è di stringere il target: scegliere un ruolo junior preciso (es. product, content o growth marketing), un settore e—se possibile—un fuso orario compatibile. Questa chiarezza non serve a “ingabbiarsi”, ma a dare coerenza a CV, LinkedIn e conversazioni. Subito dopo, suggerirei di creare prove concrete del vostro valore: in 6–8 settimane potete costruire un mini-portfolio con tre pezzi reali, per esempio l’audit di una landing universitaria con cinque correzioni prioritarie, un piccolo esperimento di crescita per un’associazione/PMI locale (obiettivo, ipotesi, esecuzione, risultato) e un contenuto long-form con CTA (call to action) e UTM per misurare le performance. Questi artifact contano più di dieci lettere motivazionali, perché aiutano i recruiter a immaginarvi “in sedia” dal giorno uno.
Poi lavorate su posizionamento e outreach. CV e profilo LinkedIn devono parlare per impatti, non per mansioni: azione, leva usata, metrica o prova del risultato. L’“Open to Work” va impostato in modo chirurgico, e nella sezione Featured inserite il portfolio. Parallelamente, non limitatevi alle candidature: scrivete a hiring manager e alumni con osservazioni specifiche e un piccolo valore in regalo. È il modo più rapido per trasformare silenzi in colloqui. Arrivati all’intervista, preparate tre storie STAR—successo, errore, conflitto costruttivo—e una mini-presentazione “Primi 90 giorni nel vostro team”: cosa misurereste, quali quick wins provereste, come impostereste dashboard e backlog di esperimenti. Comunica esecuzione, non solo teoria.
Infine, curate logistica e mindset: si può partire da ruoli limitrofi (eventi, marketing operations, comunicazione) se offrono velocità di apprendimento e contesto internazionale; il nome del titolo iniziale conta meno della pendenza della curva. Dedicate ogni giorno 90 minuti a una skill tecnica e a una di comunicazione, chiedete feedback presto (sui draft, non a lavoro finito) e ricordatevi di “mettere i numeri nelle conversazioni creative”.
Se dovessi riassumere: scegliete un contesto globale, prendete ownership di qualcosa di reale, misurate l’impatto e raccontatelo bene. È la scorciatoia più onesta che conosca per partire veloci—anche all’estero.
Dal percorso di Serena emerge con chiarezza un messaggio: la carriera internazionale non è il frutto di colpi di fortuna, ma di scelte mirate, responsabilità assunte presto e capacità di misurare e raccontare l’impatto del proprio lavoro. La sua esperienza in QS conferma quanto contino oggi le competenze ibride—tra numeri, comunicazione e gestione dei progetti—così come la capacità di interpretare il cambiamento continuo della formazione superiore.
Le sue riflessioni, arricchite anche grazie al contributo della collega Michelle Wieser, ci ricordano che le business school più competitive sono quelle capaci di unire rigore accademico, accessibilità, impatto sociale e una forte rete alumni.
In un mondo in cui le traiettorie professionali sono sempre meno lineari, l’esperienza di Serena Ricci dimostra che la combinazione di visione internazionale, ownership e capacità di apprendimento continuo resta la chiave per distinguersi e crescere.